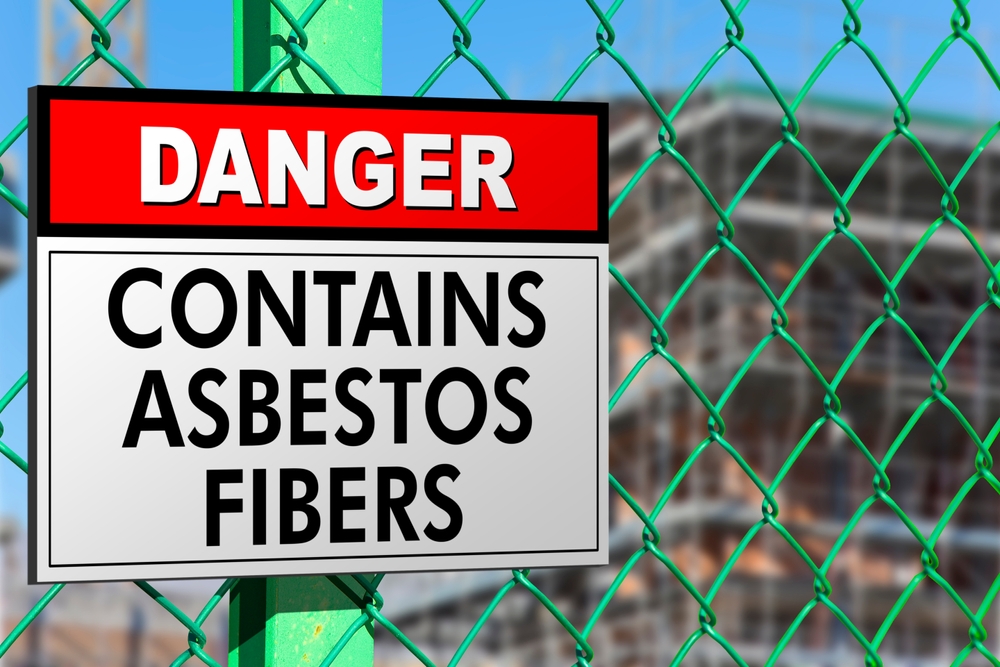Pubblicato in volume la prima mappatura sugli standard tecnici da usare nei processi di simbiosi industriale. Ventitré gli esperti che si sono cimentati nel variegato mondo delle norme tecniche con l’obiettivo di fornire una guida pratica per gli operatori del settore
La simbiosi industriale è la quintessenza della transizione ecologica. Ovvero un lavoro di squadra e di tessere che s’incastrano per ricomporre un puzzle che senza una volontà politica non esisterebbe. Un puzzle per creare valore dalla cooperazione, ribaltando i meccanismi classici della competizione tra attori e dando ragione al dilemma del prigioniero, ovvero che solo cooperando si possono raggiungere risultati migliori.
È questo uno dei tanti fronti su sui lavora l’ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, che dal 2017 ha messo in piedi la rete SUN, Symbiosis Users Network, mettendo in rete una quarantina di organizzazioni che afferiscono al mondo della ricerca, delle imprese, della pubblica amministrazione e della società civile, per tracciare un percorso condiviso di simbiosi industriale, anche per favorire una applicazione estesa e sistematica di tale strategia sul territorio nazionale.
La definizione degli standard tecnici
Per darsi degli standard tecnici condivisi e chiari a tutti il Gruppo di Lavoro 4 del SUN “Certificazione e standard per la simbiosi industriale” ha appena pubblicato un volume che vuole offrire “un quadro ampio ed organico degli standard esistenti finalizzata a fornire supporto alle organizzazioni che si approcciano o già praticano la simbiosi industriale”. Gli standard tecnici, infatti, sono determinanti per accompagnare l’implementazione di modelli concreti di simbiosi industriale, utili anche per il trasferimento tecnologico e di diffusione dell’innovazione, e come tali sempre più spesso richiamati dalle regola nazionali (es. Strategia italiana per l’economia circolare), europee (es. Green Deal) e mondiale (es. gli SDGs dell’ONU).
Come riporta il documento, in sintesi “la standardizzazione fornisce un linguaggio comune (corsivo nostro, nda) alle diverse organizzazioni per comunicare, trasferire e condividere risorse e modus operandi. L’utilizzo di standard può inoltre facilitare l’identificazione di aree di simbiosi, nonché il monitoraggio e la misurazione dell’impatto delle attività esistenti e che verranno poste in essere. Una cassetta degli attrezzi fondamentale, quindi.
La metodologia ENEA
Il lavoro si snoda tra esempi concreti di simbiosi industriale, partendo da quello che viene definito metodologia ENEA, sinteticamente descritta come un approccio “a rete”, ovvero uno strumento di tipo conoscitivo/relazionale finalizzato a consentire l’incontro tra domanda e offerta di risorse tra interlocutori che per attività economica e sociale non hanno altrimenti occasione di incontro. A differenza degli approcci basati sui distretti di simbiosi e sui parchi eco-industriali, il modello a rete è meno vincolante e consente di realizzare interventi variabili nel tempo e nello spazio (modello batch). Tre sono i pilastri fondamentali di questo modello:
- Il linguaggio: vengono utilizzate schede di raccolta dati, elaborate da ENEA per la raccolta delle informazioni relative all’azienda (scheda anagrafica), alle risorse input di cui le aziende hanno necessità per i propri processi produttivi e alle risorse output che le aziende possono mettere in condivisione (residui sottoprodotti, rifiuti, ecc.)
- La comunicazione con le aziende e con i principali stakeholder, al fine di creare un network di interlocutori, che vengono invitati a partecipare ad un tavolo di lavoro (TdL), durante il quale le organizzazioni presenti mettono a disposizioni le risorse che vogliono condividere al fine di individuare potenziali sinergie
- La conoscenza e l’esperienza, che consentono di individuare le potenziali sinergie tra le diverse organizzazioni
Alcuni casi concreti di simbiosi industriale
Passando in rassegna alcuni casi concreti italiani, il documento cita il progetto CLOSED – Closed Loop Management System) nei distretti industriali di Prato, Lucca e Pistoia, nato con l’obiettivo di costruire una comunità in cui imprese, enti locali e cittadini per la realizzazione di un sistema integrato per la gestione dei rifiuti, delle acque e dei trasporti in tre distretti industriali della Toscana in cui sono localizzati processi produttivi che l’Unione europea ha da tempo individuato per il rilievo dei loro impatti ambientali (settore tessile di Prato, vivaistico di Pistoia e cartario di Lucca).
A livello europeo viene citato il progetto “Manresa en Simbiosi” sviluppato dal Municipio di Manresa, capitale della regione del Bages in Catalogna, con l’obiettivo principale di dare avvio al primo progetto di Simbiosi industriale della regione e di promuovere l’economia circolare nel settore delle imprese del Bages. Mentre a livello mondiale viene ricordato il caso dell’area industriale di Kwinana, nell’area industriale di Perth, in Australia.
Ben 63 le norme tecniche esaminate
Il piatto forte del documento, e anche quello più tecnico, è relativo all’ampia rassegna sulle svariate norme tecnica attualmente disponibili, offrendo molti spunti di riflessione e una chiave di lettura per l’applicazione ragionata di queste nell’implementazione di un sistema di simbiosi industriale. Sono ben 63 le norme tecniche esaminate, in rigoroso ordine d’apparizione dall’”AFNOR XP X 30-901 sui Sistemi di gestione dei progetti di Economia Circolare – Schemi di gestione e audit” all’”UNI/TS 11820 Misurazione della circolarità – Metodi ed indicatori per la misurazione dei processi circolari nelle organizzazioni (UNI1608856)”
Alcuni punti chiave emersi dal documento
Il testo si chiude con tracciando un filo rosso tra tutti i documenti esaminati, dai quali se ne ricavano alcune considerazioni, così brevemente riassumibili:
- Proliferazione degli standard: l’analisi degli standard volontari in ambito internazionale e nazionale ha evidenziato un gran numero di standard che si prestano a una potenziale applicazione nell’ambito della simbiosi industriale
- Segmentazione degli aspetti tracciati: gli standard che trattano in maniera completa la simbiosi in termini di organizzazione sono pochi e tendono ad essere focalizzati su aspetti molto specifici
- Forte evoluzione dei sistemi di tracciatura, nel senso che si tratta di un processo in perenne fermento, nonostante si stia lavorando molto per arrivare a modelli il più possibile uniformi
- Mancanza di indicatori “ad hoc”: nel senso che l’impostazione della standardizzazione in chiave di singola organizzazione e non di gruppo di organizzazioni può pregiudicare la tracciatura di aspetti salienti delle attività di simbiosi industriale come ad esempio quelli legati alle cooperazioni locali
- Mancanza aspetti di collaborazione e comunicazione: gli indicatori di simbiosi adottabili in base a schemi diversi non tengono frequentemente conto della “dimensione di collaborazione e relazionale della simbiosi” tendendo a fornire invece una tracciatura “interna” di tali attività
- Focus sui materiali ed energia e non sulle risorse: gli standard analizzati hanno riguardato prevalentemente risorse materiche ed energetiche mentre il concetto di simbiosi investe l’ambito più generale delle risorse
I prossimi passi
Guardando al futuro, i ricercatori sottolineano la necessità di lavorare sull’informatizzazione e sulla modularizzazione dei dati, così come sul rafforzamento della collaborazione tra attori, con gli occhi puntati sempre sulle policy locali, arrivando ad allineare gli standard alle normative locali. Senza trascurare la necessità di arrivare in un futuro prossimo a una concezione di standard “ad hoc”, ovvero nuovi standard pensati appositamente per trattare la tematica della simbiosi che superino ed integrino gli standard esistenti in un’ottica di miglior gestione di questo paradigma.