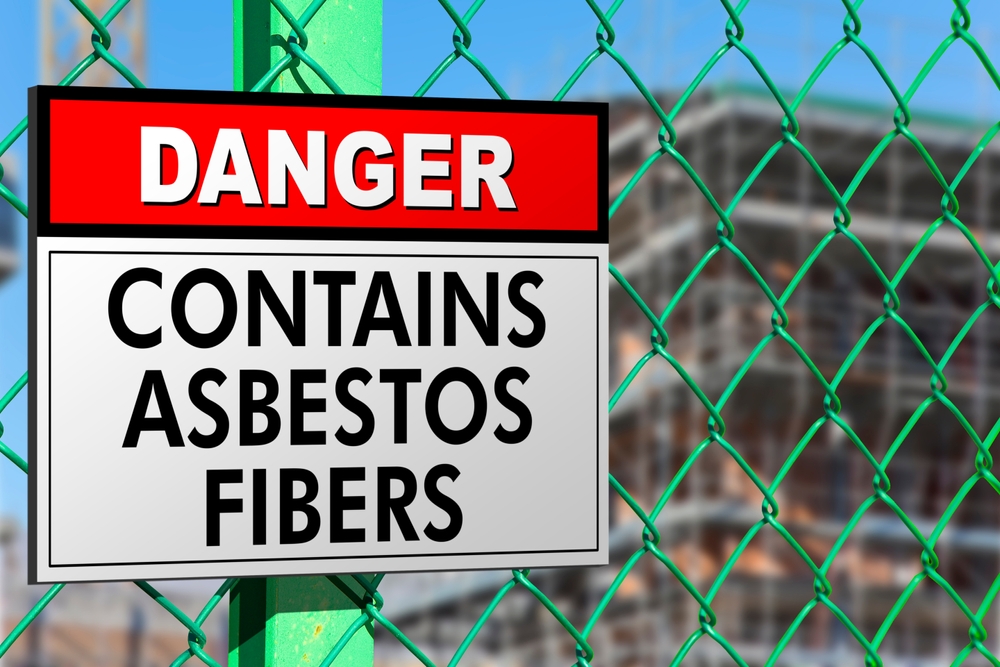Puntare sugli argini naturali e sulla rinaturalizzazione dei corsi d’acqua significa adottare una visione lungimirante che protegge i territori, valorizza la biodiversità e crea paesaggi resilienti. Un investimento sostenibile per il presente e per il futuro.
Proteggere i territori dalle piene aumentando la biodiversità con argini naturali è oggi una strategia concreta e sostenibile per affrontare le sfide poste dai cambiamenti climatici. Nel contesto dell’emergenza climatica e dell’aumento degli eventi meteorologici estremi, cresce l’interesse per soluzioni che possano proteggere efficacemente i territori senza compromettere gli ecosistemi. Tra queste, la naturalizzazione degli argini e la gestione sostenibile dei fiumi si stanno affermando come strategie chiave per unire sicurezza e tutela ambientale. Gli argini naturali, rispetto a quelli artificiali, offrono una difesa più resiliente e integrata, favorendo la biodiversità e restituendo spazio alla natura. Vediamo quindi come utilizzarli al meglio.
Il ruolo degli argini naturali nella prevenzione delle inondazioni

L’aumento delle piogge intense e la frequenza delle piene fluviali richiedono un nuovo approccio alla gestione del rischio idraulico. Gli argini naturali, progettati per integrarsi con il paesaggio e lasciare maggiore libertà al corso d’acqua, rappresentano una forma di difesa idraulica ecocompatibile. A differenza delle soluzioni rigide e artificiali, questi interventi riducono la velocità delle acque in piena, ne assorbono la forza e diminuiscono il rischio di rotture improvvise.
Funzionamento e vantaggi rispetto agli argini artificiali
Un argine naturale non è solo un contenimento fisico, ma un elemento dinamico e vegetato che interagisce con il fiume. L’uso di piante erbacee e arbustive lungo i bordi favorisce il consolidamento del terreno e consente al fiume di espandersi in modo controllato, riducendo l’effetto “imbuto” che spesso caratterizza gli argini in cemento. Inoltre, questi sistemi hanno numerosi vantaggi.
- Ammortizzano le onde di piena: gli argini naturali, grazie alla loro struttura più permeabile e adattabile, sono in grado di assorbire e rallentare il flusso delle acque durante eventi di piena. Le piante che rivestono le sponde contribuiscono a ridurre l’energia del flusso, prevenendo l’erosione del terreno e proteggendo le aree circostanti.
- Favoriscono l’infiltrazione dell’acqua nel suolo: gli argini naturali sono costruiti con materiali che permettono una maggiore infiltrazione dell’acqua piuttosto che il suo scorrimento superficiale. Ciò riduce il rischio di inondazioni improvvise, in quanto l’acqua viene assorbita progressivamente nel terreno, ricaricando anche le falde acquifere.
- Richiedono meno manutenzione nel tempo: gli argini artificiali necessitano di interventi costanti per prevenire danni strutturali come crepe o frane. Al contrario, gli argini naturali, una volta stabilizzati, richiedono meno manutenzione, in quanto la vegetazione naturale contribuisce a consolidare il terreno e a proteggerlo dagli agenti atmosferici.
- Offrono valore paesaggistico e ricreativo alle comunità locali: con la loro vegetazione lussureggiante e la biodiversità che ospitano, gli argini naturali migliorano il paesaggio fluviale, creando spazi verdi che possono essere utilizzati per attività ricreative, escursioni o semplicemente come aree di svago per le comunità locali. Questo aspetto rappresenta un valore aggiunto, in quanto favorisce la qualità della vita e la connessione con l’ambiente naturale.
Benefici ecologici e per la biodiversità
Oltre alla funzione protettiva, gli argini naturali offrono benefici ecologici fondamentali. Secondo il dossier sulla biodiversità di Legambiente, il 16% della superficie italiana presenta ecosistemi considerati a elevato rischio e un ulteriore 20% ospita ecosistemi a rischio che potrebbero peggiorare. Tra le cause principali ci sono le attività umane, dirette o indirette, il consumo e l’inquinamento del suolo.
La biodiversità fluviale – ovvero l’insieme di specie animali e vegetali che popolano gli ambienti d’acqua dolce – trae grande vantaggio dalla presenza di ambienti semi-naturali. Le zone umide ripristinate, le sponde vegetate e le aree di esondazione controllata diventano habitat ideali per anfibi, uccelli, insetti impollinatori e piccoli mammiferi. La naturalizzazione degli argini favorisce la ricolonizzazione spontanea di specie autoctone, il miglioramento della qualità dell’acqua e quindi la resilienza degli ecosistemi alle alterazioni climatiche.
Connessioni ecologiche e corridoi verdi
Uno degli aspetti più innovativi degli argini naturali è la loro capacità di connettere ambienti diversi, creando corridoi ecologici continui lungo i fiumi. Questi corridoi verdi permettono la migrazione della fauna, il trasporto dei semi e la comunicazione tra habitat che altrimenti sarebbero isolati. In particolare, i progetti che prevedono la ricostruzione delle fasce ripariali favoriscono il passaggio di specie forestali e acquatiche e la continuità ecologica tra aree protette. Inoltre sono indispensabili per il mantenimento della salute degli ecosistemi locali.
Progetti e strategie di rinaturalizzazione in Italia
Anche in Italia, l’approccio della rinaturalizzazione dei fiumi sta guadagnando terreno. Le zone più critiche sono in Pianura Padana e lungo la Costiera Adriatica. Il progetto di rinaturazione del fiume Po, recentemente approvato nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mira a migliorare gli equilibri ecologici e morfologici lungo il corso del fiume. Con 56 aree di intervento, l’iniziativa punta a ridurre l’artificialità del fiume, favorendo la biodiversità tramite rimboschimenti e il contrasto alle specie invasive. Sarà cruciale un piano di monitoraggio accurato per valutare l’efficacia del progetto e apportare eventuali correttivi. L’obiettivo è replicare queste strategie in altri corsi d’acqua.
Un altro esempio virtuoso è rappresentato dal progetto condotto dall’Università di Pisa. Creato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Toscana Nord sulla base della ricerca “Argini gioriti- wildflowers”, sperimenta l’uso di fiori selvatici sugli argini per unire stabilità strutturale e valorizzazione della biodiversità. Questi interventi dimostrano come sia possibile combinare sicurezza idraulica e bellezza del paesaggio. Altri progetti mostrano come le soluzioni nature-based, ossia interventi ispirati ai processi naturali, siano in grado di ripristinare le pianure alluvionali, ricreare alvei secondari e aree di esondazione naturale e aumentare la capacità di assorbimento del suolo rallentando le piene.
In Europa un altro esempio virtuoso è il progetto sul fiume Mosa in Olanda, avviato nel 2007, che mira a contrastare 500 anni di ingegneria idrica dannosa. Completato su 50 km, ha già mostrato un aumento della biodiversità. Separando la natura dall’agricoltura, le aziende si sono spostate, migliorando la salute del fiume e garantendo la sicurezza durante l’alluvione del 2021. La rinaturalizzazione ha anche potenziato i servizi ecosistemici, aumentando la fertilità del terreno e la capacità di immagazzinare acqua, cosa che ha portato tanti benefici alle attività agricole. Sebbene alcuni lavoratori abbiano perso il posto, il turismo nella zona è cresciuto, creando nuove opportunità. Ma anche altre capitali europee come Barcellona, Londra e Parigi si stanno muovendo sulla stessa strada.
Investire in queste soluzioni è essenziale per costruire un futuro più resiliente e armonioso tra uomo e natura.