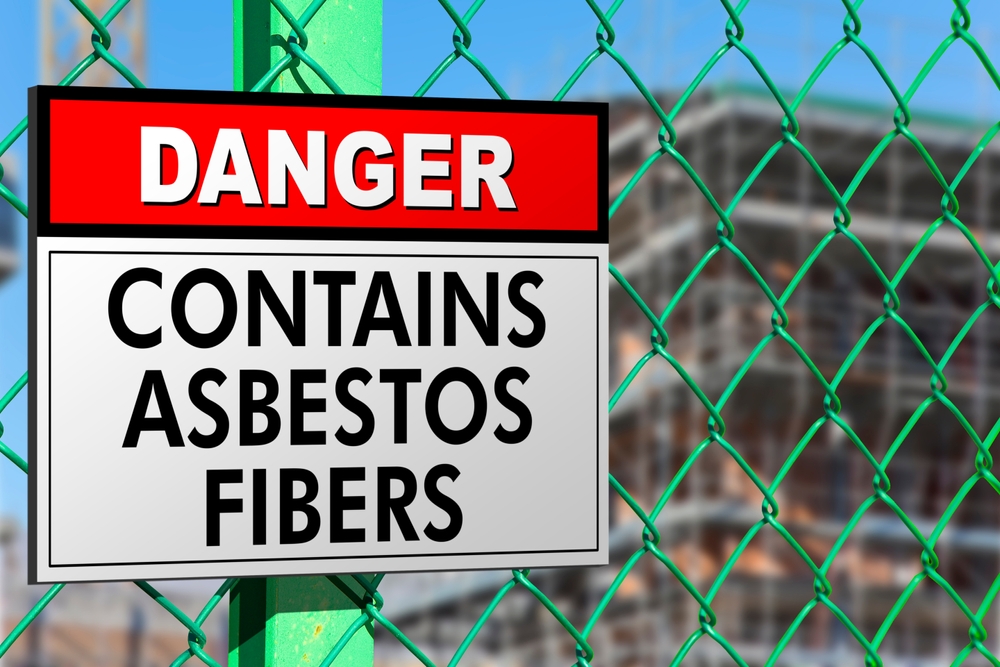L’inquinamento da plastica è un serio problema e minaccia l’intero pianeta. Figure innovative come quella del chimico verde possono guidare la lotta a questo materiale, limitandone l’impatto prima che superi la soglia dell’irreversibilità.
La nostra casa comune, come tristemente sappiamo, è sommersa dalla plastica. Macro, micro, dura, morbida, visibile, invisibile… il polimero ci ha invaso.
C’è però un architetto della materia appositamente formato per riscrivere le regole di un gioco che, a oggi, stiamo malamente perdendo: il chimico verde. Questo professionista non si limita a ripulire il danno. Lavora alla radice, applica i principi della chimica sostenibile e crea processi che riducono l’inquinamento sin dallo step progettuale. Si tratta di una figura chiave in un’ottica di tansizione ecologica. La sua missione è duplice: da un lato, sviluppa metodi di riciclo chimico mentre dall’altro crea bioplastiche da fonti rinnovabili.
Cosa fa un chimico verde: l’architetto della materia sostenibile
Possiamo definire il chimico verde come un ingegnere della sostenibilità. Ciò significa che la sua filosofia d’azione è fondamentalmente pratica, tanto da poter essere detta ingegneristica, e il suo scopo è massimizzare la sostenibilità dei processi produttivi e operativi. Sintetizziamo il suo modo di essere e agire secondo il dodecalogo dei principi della chimica verde, che rappresentano la mission di questa nuova figura professionale:
- è meglio prevenire la comparsa di rifiuti che essere costretti a doverli smaltire;
- se in ogni reazione chimica ci si pone l’obiettivo di incorporare la maggior quantità possibile di atomi dei reagenti nel prodotto finale, si possono ridurre gli scarti generati (principio dell’efficienza atomica);
- vanno utilizzate e create sostanze dalla tossicità ridotta;
- ogni composto chimico deve dimostrarsi efficace, ma non può essere tossico per l’uomo e/o per l’ambiente;
- occorre evitare di fare uso di solventi nocivi e sostituirli con sostanze ecologiche;
- tutte le volte che sia possibile, occorre condurre reazioni a temperatura e pressione ambiente;
- le fonti fossili utilizzate nella sperimentazioni vanno sostituite con biomasse;
- è il caso di minimizzare i passaggi intermedi in laboratorio, come per esempio le reazioni di protezione, che generano scarti inutili;
- è necessario fare uso dei catalizzatori: sostanze che accelerano le reazioni, riducendo il consumo energetico, e possono essere riutilizzati;
- i prodotti chimici impiegati nelle reazioni devono potersi decomporre in sostanze innocue, al termine dell’uso;
- tutti i processi vanno monitorati costantemente, per poter agire tempestivamente, all’occorrenza;
- le sostanze chimiche usate vanno scelte accuratamente, allo scopo di minimizzare il rischio di incidenti.
I campi di azione della professionalità di un chimico verde sono piuttosto vasti. Il tecnico può spaziare dall’energia alla farmaceutica, dalla cosmetica ai materiali. Il suo obiettivo è creare una chimica che imiti i cicli chiusi della natura, per la quale il concetto stesso di rifiuto non esiste. È questo che intendiamo quando parliamo di circolarità. Qualora lo scarto sia utilizzabile come nuovo punto di partenza, ben venga. Altrimenti lo si converte in energia, spendibile per il sostentamento del processo.
Riciclo meccanico e chimico: una battaglia tra titani
Per decenni, l’unico possibile approccio al recupero delle plastiche è stato quello del riciclo meccanico, basato sulla triturazione, sul lavaggio e sulla fusione della plastica di scarto. Questo processo è economico e non causa grande dispendio energetico. Ha però seri limiti, in quanto restituisce plastiche di bassa qualità e non è in grado di trattare scarti sporchi o monomateriali.
Il riciclo chimico non va visto come concorrente, ma semmai come complemento necessario al meccanico, in grado di trattare quel 70-80% di scarti (!) che oggi non vengono recuperati, chiudendo davvero il ciclo. Questo trattamento scompone la plastica nelle sue molecole base, dette monomeri, generando materie prime vergini in grado di creare nuova plastica, di altissima qualità. I rifiuti più complessi, come quelli misti o sporchi, possono essere trattati chimicamente.
| CARATTERISTICA | RICICLO MECCANICO | RICICLO CHIMICO |
| Rifiuto gestito | Principalmente plastiche pulite e omogenee (per esempio, le bottiglie in PET). | Plastica mista, sporca o multistrato (per esempio, gli imballaggi alimentari). |
| Qualità del prodotto finale | Inferiore all’originale (si parla di downcycling). | Comparabile all’originale, talvolta persino superiore (upcycling). |
| Efficienza energetica | Tipicamente più elevata del ciclo chimico. | Inferiore a quella del ciclo meccanico: i processi sono molto più complessi. |
| Stato tecnologico | Maturo; la tecnologia è ampiamente adottata. | In evoluzione; la tecnologia è ancora definibile di nicchia. |
3 Tecnologie di riciclo chimico che stanno cambiando tutto
I chimici verdi stanno sviluppando alcune differenti tecnologie per decomporre le plastiche, riportandole alle molecole monomeriche. Le tre soluzioni più promettenti, sulle quali al giorno d’oggi possiamo puntare, sono:
- pirolisi. Immaginiamo di cucinare la plastica, a fuoco lento, in una pentola chiusa e in assenza di ossigeno. Le alte temperature scomporranno le lunghe catene polimeriche in molecole più piccole, generando un vero e proprio olio (chiamato non a caso olio di pirolisi) e un gas. Ambedue riutilizzabili. L’olio di pirolisi può essere reintrodotto nelle raffinerie, al fine di produrre nuovi polimeri o carburanti. Il gas è generalmente utilizzato per alimentare il reattore pirolitico ove avviene il processo;
- depolimerizzazione. Si tratta della tecnica più precisa che abbiamo a disposizione. Utilizza agenti chimici quali catalizzatori, acqua calda o anche alcol, allo scopo di smontare selettivamente un polimero, come per esempio il PET delle bottiglie, nei suoi monomeri puri di partenza. Questi si presentano come chimicamente identici a quelli vergini e possono essere riassemblati. Il processo può generare nuova plastica, di elevata qualità, e farlo all’infinito;
- gassificazione. Quest’operazione, dalla complessità inferiore rispetto alla precedente, trasforma la plastica in un gas di sintesi, noto come syngas e composto principalmente di monossido di carbonio e idrogeno. Questo versatile blocco chimico può essere utilizzato nella produzione di carburanti, metanolo o altri composti in grado di fornire energia.
Il mercato del riciclo chimico è in crescita, dal momento che sempre più frequentemente si sceglierà di trattare la plastica in questa maniera. O almeno è quel che auspichiamo. Secondo una stima di McKinsey, l’indotto del settore (che oggi vale poco più di 2 miliardi di dollari) ammonterà a più di 70 miliardi, entro la fine del 2030.
Dalla teoria alla pratica: come si diventa chimico verde
Ma come si acquisiscono le competenze necessarie a svolgere questa professione? Il percorso formativo di un chimico verde inizia, tipicamente, con una laurea in chimica o ingegneria chimica. Spesso, a essa seguono una specializzazione, o un dottorato, incentrato su temi di sostenibilità, materiali o processi a basso impatto. È una formazione serrata e piuttosto selettiva, ma è inevitabile. Il ruolo della ricerca resta fondamentale. I veri progressi, dopotutto, si generano in seguito a fitte collaborazioni tra università e aziende.
I giovani ricercatori, la vera linfa di questa categoria professionale, portano abitualmente i risultati di laboratorio nelle linee di produzione industriale. Al momento, i team di ricerca sono focalizzati sullo sviluppo di nuovi catalizzatori verdi, che rendano le reazioni di riciclo veloci, più selettive e meno energivore.
Non solo riciclo, ma anche creazione dal nuovo
Il chimico verde non si limita a recuperare la plastica già utilizzata. È anche in prima linea nella creazione di nuove soluzioni, denominate dalla culla alla tomba, poiché si mantengono basso-impattanti da quando vengono create in laboratorio a quando vengono dismesse.
Come ricorda Assobioplastica, nel settore delle bioplastiche il nostro Paese è uno dei leader mondiali. Lavorando con materie prime rinnovabili, come per esempio amido di mais, canna da zucchero o alghe, il chimico verde progetta polimeri compostabili o biodegradabili. Non si tratta soltanto di plastica fatta diversamente, bensì di materiali sostenibili, studiati allo scopo di poter essere riutilizzari alla fine del loro ciclo di vita. Offrono dunque una valida alternativa alla plastica tradizionale.
Il chimico verde, grazie al suo approccio specifico, basato su innovazione e responsabilità, può porsi come vero motore di quella rivoluzione circolare di cui il nostro pianeta ha urgente bisogno. Ha le competenze e la sensibilità giuste per spingerci a modificare radicalmente l’approccio al consumo e alla scienza, adottandone di più coerenti con il pianeta. Naturalmente, le innovazioni che porta non saranno disponibili domani. È perciò necessario iniziare a vivere in maniera meno impattante, riducendo la nostra dipendenza dalla plastica prima che la scienza ci fornisca nuovi strumenti. Se attenderemo la svolta prima di attivarci, correremo il rischio di muoverci colpevolmente troppo in ritardo.