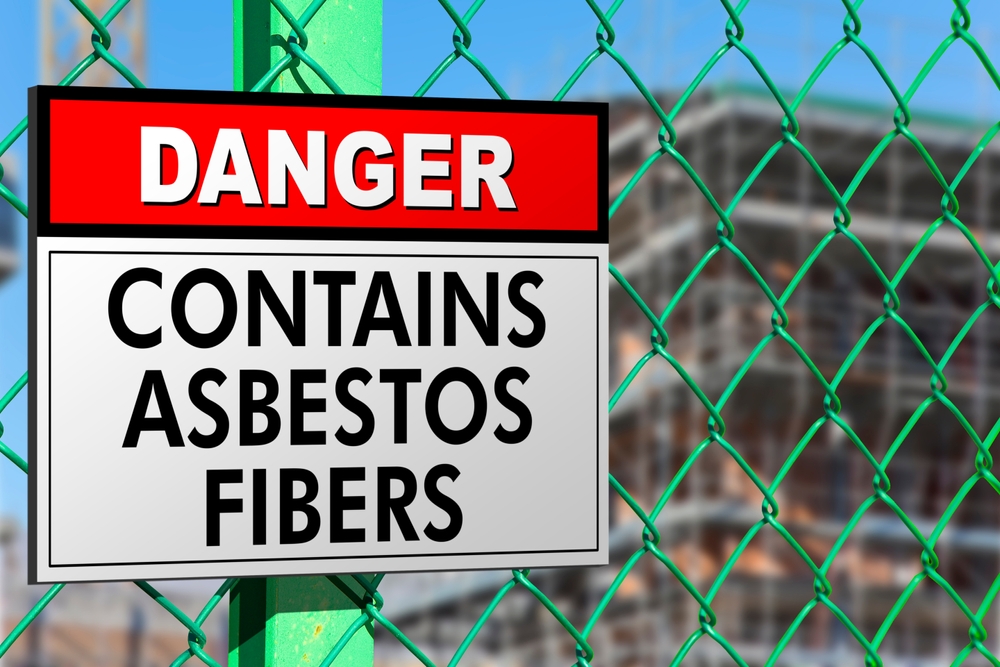Uno studio del Politecnico di Milano mette in luce le potenzialità del fotovoltaico galleggiante in Italia, una tecnologia green per gestire contemporaneamente energia e acqua.
Installare impianti di fotovoltaico galleggiante su appena il 2% delle superfici d’acqua italiane – circa 6.000 ettari – consentirebbe di generare fino a 4.000-5.000 megawatt di potenza, con un investimento stimato di 3,5 miliardi di euro. È il risultato di una ricerca portata avanti dal Politecnico di Milano sulle potenzialità del fotovoltaico galleggiante in Italia, sia in termini di produzione di energia pulita e di decarbonizzazione, che di tutela della risorsa idrica. Un lavoro, finanziato in parte dal gruppo Mediapolis, volto a sostenere lo sviluppo di questa tecnologia, considerata ormai matura, in una chiave che coniughi la gestione dell’energia con quella dell’acqua e della sua conservazione e, di riflesso, interessi la mitigazione del dissesto idrogeologico.
Il progetto è portato avanti dalla “Piattaforma nazionale bacini idrici e fotovoltaico galleggiante”, tuttora in fase di costituzione, che punta a costruire un dialogo continuativo con le istituzioni nazionali ed europee, promuovendo il riconoscimento del fotovoltaico galleggiante come infrastruttura strategica per la transizione energetica e la gestione sostenibile delle acque. L’idea, in questo senso, è che “la perdita di disponibilitàdi acqua conseguente al fenomeno del cambiamento climatico e all’evaporazione sia mitigabile con la posa di fotovoltaico galleggiante su specchi d’acqua di bacini destinati in precedenza a un utilizzo solo idrico e contestuale”, spiega Gian Franco Fabbri di Mediapolis Engineering.
In crescita il mercato mondiale
“Il fotovoltaico galleggiante è una tecnologia consolidata, ampiamente validata su scala reale in Asia, Europa e America Latina, con oltre 13 gigawatt già installati nel mondo. Le principali sfide tecnologiche – dalla corrosione al comportamento meccanico in acqua, dagli ancoraggi ai flussi di carico, fino alla gestione dell’efficienza termica – sono state risolte con soluzioni tecniche standardizzate e già applicate su larga scala”, prosegue Fabbri, sottolineando come “i numeri non descrivano un mercato emergente, ma un comparto già ampiamente industrializzato e in piena espansione”.
Nel 2024 il mercato globale del fotovoltaico galleggiante è stimato tra i 6,7 e i 16 miliardi di dollari, a seconda dell’ampiezza del perimetro considerato. Secondo Precedence Research, il valore è pari a 6,69 miliardi di dollari, con una crescita attesa fino a 75,76 miliardi entro il 2034 e un tasso annuo composto del 27,5%. Altri analisti, come MarkNtel Advisors, collocano il valore 2024 a 15,98 miliardi di dollari, con proiezioni che raggiungono i 144,92 miliardi entro il 2030, con una crescita media superiore al 40% l’anno.
Risultati dello studio del Politecnico di Milano
Da qui l’interesse per le potenzialità di applicazione della tecnologia in Italia e lo studio affidato al Politecnico di Milano, portato a sintesi in un articolo pubblicato sulla rivista internazionale Sustainability, a firma di Virginia Marini, Daniele Fabrizio Bignami e Giovanni Menduni dello stesso Politecnico. Obiettivo: valutare se il nostro territorio sia adatto a ospitare impianti di fotovoltaico galleggiante su specchi d’acqua. Conclusione: “è effettivamente possibile utilizzare questa tecnologia in Italia, segnando un grande passo in termini di innovazione”, scrivono gli autori.
Lo studio è stato condotto su scala nazionale, articolato in due fasi: una selezione degli specchi d’acqua idonei, poi una prioritizzazione mediante punteggi. Al fine di individuare i siti sicuramente idonei, è stato adottato il criterio precauzionale di escludere i corpi idrici situati all’interno di aree protette, ricavandone i dati dal World Database on Protected Areas. Le analisi sono state quindi effettuate solo sui corpi idrici “non vincolati”, che sono 63.869 e occupano una superficie di 423,7 chilometri quadrati. Considerando che la maggior parte dei grandi laghi italiani si trova in aree protette, con la loro esclusione a priori la perdita in termini di superficie è del 28,7%, si legge nella metodologia della ricerca.
Di particolare interesse i laghi di cava e i bacini idroelettrici
Particolare attenzione è stata rivolta ai laghi di cava presenti nella pianura italiana, con l’idea che potrebbero essere riqualificati con l’installazione di impianti di fotovoltaico galleggiante. I laghi di cava, piuttosto diffusi in Italia, hanno origine a causa dell’affioramento della falda freatica a seguito delle attività minerarie e sono associati a vari possibili impatti, legati principalmente ai cambiamenti nella morfologia della falda freatica o alla sua contaminazione con sostanze inquinanti pericolose. Il loro ripristino ambientale è dunque una questione attuale e comune.
Uno dei modi per attuarlo potrebbe essere quello di installarvi impianti di fotovoltaico galleggiante: ciò consentirebbe di produrre energia rinnovabile e, allo stesso tempo, di controllare e proteggere la falda freatica esposta da possibili pericoli o abusi. “Se i laghi di cava non vengono monitorati o sorvegliati, il rischio che diventino discariche abusive o luoghi soggetti a usi incompatibili potrebbe essere non trascurabile. Al contrario, un impianto di fotovoltaico galleggiante, che necessita di una sorveglianza permanente, potrebbe proteggere il corpo idrico dagli inquinanti e dal degrado, grazie al suo ruolo di limitazione dell’evaporazione e della stratificazione”. Un’attenzione specifica è stata rivolta, inoltre, ai bacini destinati alla produzione idroelettrica, ritenuti particolarmente adatti all’uso integrato con il fotovoltaico galleggiante.
Un possibile risparmio annuo di 4,6 milioni di tonnellate di CO2
Tre gli scenari considerati dallo studio, più o meno favorevoli allo sviluppo della tecnologia. Nello scenario migliore, il numero di corpi idrici con una piccola porzione (pari ad esempio al 5%, 10% o 15% della superficie) superiore a un ettaro può raggiungere i 507 corpi idrici o 96 cosiddetti “corpi idrici-grandi dighe” dove è già attiva una centrale idroelettrica. Un potenziale a cui, secondo la “Piattaforma nazionale bacini idrici e fotovoltaico galleggiante” si potrebbero aggiungere i 10.000 nuovi bacini previsti dal “Piano Laghetti” promosso da ANBI (Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari). Sempre nella migliore delle ipotesi, la domanda elettrica italiana che potrebbe essere soddisfatta solo con l’energia prodotta da questi potenziali nuovi impianti si attesta quasi al 3%.
Laddove “valori, che per quanto possano sembrare esigui, sono importanti in un contesto di transizione energetica, in cui l’obiettivo è quello di dipendere sempre più dalle fonti rinnovabili e di ridurre le emissioni”, si legge nell’articolo. Infine, la quantità di anidride carbonica che potrebbe essere risparmiata ogni anno, nello scenario migliore, ammonta a 4,6 milioni di tonnellate.
Processi di autorizzazione e finanziamenti
“Per questi motivi sembra logico utilizzare questo tipo di impianti in Italia e, per farlo, è necessario incoraggiare, da un lato, un’iniziativa economica in questo settore e, dall’altro, la creazione da parte delle autorità competenti di processi di autorizzazione che ne favoriscano l’utilizzo”, concludono gli autori. Lo studio è da considerarsi come una proposta metodologica per la valutazione dell’idoneità dei siti su scala nazionale; “ad esso dovrebbe seguire un’iniziativa economica e autorizzativa nel campo degli impianti di fotovoltaico galleggiante, che preveda l’esecuzione di analisi sito-specifiche”. Il Decreto FER 2 (giugno 2024) ha introdotto incentivi specifici per impianti su acque interne e marine, che facilitano lo sviluppo del settore, ma secondo la “Piattaforma nazionale bacini idrici e fotovoltaico galleggiante” occorre un recepimento normativo e regolatorio del fotovoltaico nei piani energetici e ambientali regionali e nazionali e la sua integrazione nei programmi di finanziamento europei.