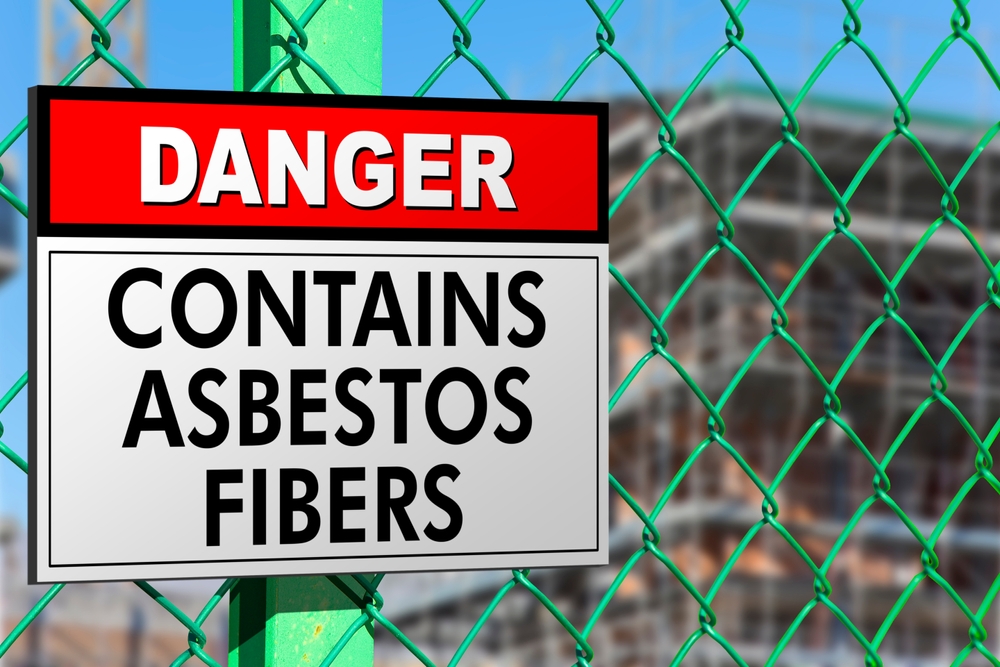Grazie agli scarti organici raccolti in maniera differenziata nel 2023 sono stati prodotti, grazie ai 363 impianti sparsi in tutta Italia, circa 2 milioni di tonnellate di compost, 475 milioni di m3 di biogas e 201 milioni di m3 di biometano
La miniera urbana degli scarti alimentari e delle frazioni organiche raccolte in maniera separata presso le abitazioni degli italiani (tecnicamente definiti come frazione organica dei rifiuti urbani) sono state nel 2023, secondo i dati ufficiali di Ispra, circa 5,5 milioni di tonnellate, con una media nazionale pro capite di 126,6 kg/abitante, che aggiungendo anche la frazione del verde urbano (manutenzione di giardini e parchi) e dai rifiuti avviati a compostaggio domestico e quelli prodotti dai mercati rionali arriva a quasi 7,5 milioni di tonnellate. Nello stesso anno, il rapporto tra i quantitativi di organico riciclati e i quantitativi raccolti in modo differenziato è stato pari all’80,9%, dato in aumento sia rispetto a quello del 2022 (79,9%) sia quello del 2021 (80,7%).
Un risultato in leggera crescita rispetto all’anno precedente, che soddisfa il Consorzio italiano compostatori (CIC), che, partendo da questi dati, ha costruito un nuovo Report pubblicato da Edizioni Ambiente all’interno del volume “Organic Biorecycling – Suoli fertili dalle nostre città”, a cura di Massimo Centemero, Direttore Generale del CIC e Vice Presidente dell’European Compost Network (associazione di categoria a livello europeo). Report che ragiona sulle prospettive presenti e future di una delle frazioni chiave nella gestione dei rifiuti urbani, quella dell’organico, filiera di vanto dell’economia circolare Made in Italy, sia per la produzione di compost di qualità che per la generazione di biogas e biometano.
La raccolta differenziata della frazione organica
In Italia dal 1° gennaio del 2022 esiste l’obbligo di raccolta differenziata della frazione organica proveniente dai rifiuti urbani. Come ricorda Ispra nei sui report annuali, essi rappresentano un flusso fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti urbani previsti dai target europei e nazionali.
La frazione organica rappresenta, infatti, più o meno il 40% del totale dei rifiuti urbani raccolti (come già detto, pari a 7,5 milioni di tonnellate), che nello stesso anno, considerando il resto delle frazioni, hanno raggiunto quota 19,5 milioni di tonnellate, con una raccolta differenziata arrivata al 66,6% (+1,4 punti rispetto al 2022).
Considerando che la produzione totale di rifiuti urbani nel 2023 è stata di 29,3 milioni di tonnellate, significa che mancano all’appello della valorizzazione più di 10 milioni di tonnellate di rifiuti, scarti finiti nella raccolta della frazione indifferenziata, quindi destinata a incenerimento e/o discarica. Ed è esattamente questa frazione indifferenziata quella sulla quale si devono concentrare i maggiori sforzi per arrivare al 2035 a non conferire in discarica più del 10% dei rifiuti urbani prodotti.
Una filiera strategica
Quella dell’organico rimane comunque una filiera strategica nella gestione dei rifiuti urbani, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, quindi economico, ovvero degli output capaci di generare, sia in termini di materia che di energia. Rispetto alle prospettive economiche, basti pensare agli incentivi riconosciuti dal GSE (Gestore servizi elettrici) per promuove l’uso del biogas (da ultimo grazie al Decreto FER II) e del biometano da impiegare nel settore dei trasporti.
Essendo, quest’ultimo, un tassello strategico verso la decarbonizzazione dell’economia, il 15 settembre 2022 è stato pubblicato il terzo Decreto Biometano che prevede corposi incentivi che consistono in un finanziamento a fondo perduto – con le risorse del PNRR – fino al 40% dell’investimento totale per la realizzazione dell’impianto di produzione, più un incentivo tariffario che per gli impianti agricoli si aggira intorno ai 125 euro/MWh, valore variabile nel tempo secondo regole di aggiornamento piuttosto complesse.
Una filiera integrata, appunto, capace di recuperare sia materia organica a beneficio soprattutto dei terreni agricoli e di bioenergia, sia per produzione elettriche (biogas) che per autotrazione (biometano).
Impianti, compost ed energia prodotta
Tornando all’analisi del CIC, vi si può leggere che il sistema impiantistico nazionale si regge su 363 impianti operativi per il riciclo dei rifiuti organici (in crescita di 7 unità rispetto all’anno precedente), che hanno trattato complessivamente 8,7 milioni di tonnellate di rifiuti a matrice organica, generando circa 2 milioni di tonnellate di compost, sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Parallelamente, dagli stessi flussi di rifiuti sono stati prodotti;
- Circa 475 milioni di m3 di biogas, la cui valorizzazione ha portato alla produzione di 470 GWh di energia elettrica e 80 GWh di energia termica, la produzione di 201 milioni di m3 di biometano, destinato principalmente ai trasporti e all’autotrazione;
- Oltre 160 milioni di m3 di anidride carbonica, parte della quale trattata e commercializzata come gas tecnico, anche all’interno dell’industria alimentare.
Verso una raccolta di qualità
L’obiettivo di fondo, fa notare il CIC, è adesso migliorare la qualità delle frazioni conferite, considerato che le frazioni estranee, frutto di raccolte fatte male, rappresenta il principale ostacolo verso la piena efficienza.
Il Consorzio ha così messo a punto anche un vademecum rivolto ai cittadini, per indirizzarli meglio verso una raccolta differenziata sempre più di qualità. Le quasi 1.600 indagini merceologiche effettuate dal CIC nel 2023, a cui corrispondono altrettanti comuni/gestori, “hanno permesso di stimare una purezza merceologica media a livello italiano del 93,6%, a cui corrisponde quindi un valore di Materiale non Compatibile (Mnc) pari al 6,4% del materiale conferito (con previsioni del 6,6% nel 2024). Questo dato conferma il progressivo peggioramento della qualità merceologica rilevato dal 2019 – in cui il valore medio era vicino al 95% – con un trend che nel 2023 mostra 1 campione su 6 incapace di raggiungere il 90% di purezza merceologica”.
L’Urban Carbon Farming, ovvero un nuovo patto per il suolo
Poste queste premesse l’analisi del CIC propone una nuova visione che valorizza il legame tra suolo e fertilizzanti organici, estendendo questo modello anche agli spazi verdi urbani attraverso l’innovativa prospettiva dell’Urban Carbon Farming, ovvero l’insieme di pratiche agricole rigenerative applicate in ambito urbano e periurbano, con l’impiego di compost e digestato.
Un approccio che riconosce al verde urbano – parchi, giardini, aiuole – una funzione essenziale non solo estetica, ma ecologica e climatica: “assorbire carbonio, ridurre le isole di calore, migliorare la qualità dell’aria e accrescere la resilienza delle città” Proprio per questo, in occasione della presentazione del volume, il Cic lancia il Manifesto dell’Urban Carbon Farming, chiamando aziende e cittadini a sostenere una visione e un insieme di pratiche concrete che puntano a rendere le città più sostenibili, vivibili e resilienti di fronte ai cambiamenti climatici puntando su una razionalità ecologica, direbbe John Dryzek, che ha nelle superfici non ancora cementificata la chiave di volta.