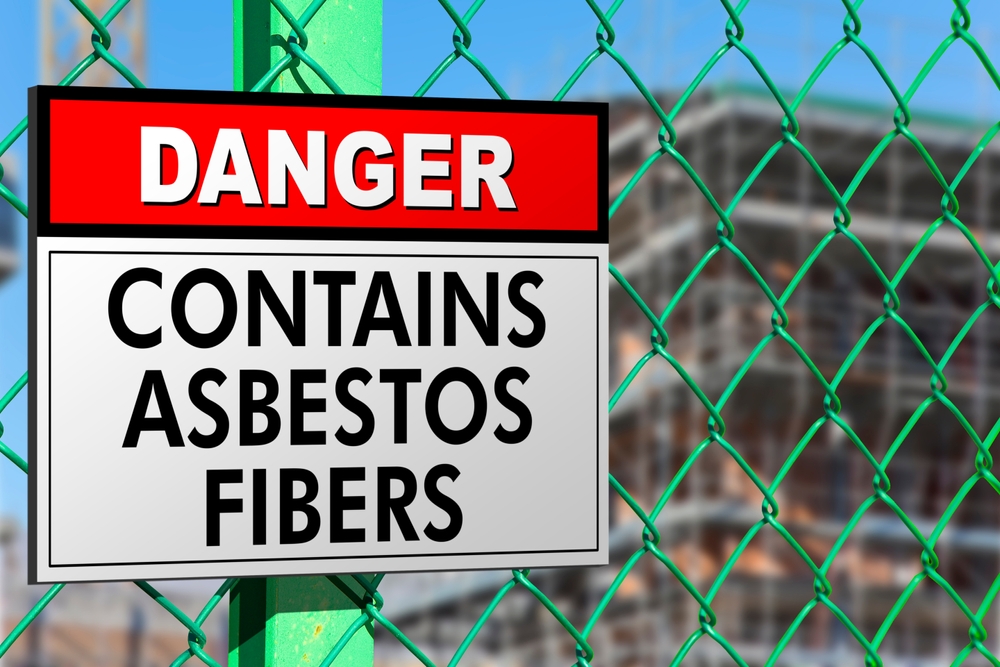Nell’ambito di Remtech Expo 2025 il tema dell’uso dell’IA a sostegno delle politiche ambientali è risuonato più volte. Se n’è discusso in maniera approfondita con esperti del settore in un panel a essa dedicata, dove è stato presentato il progetto europeo Artic.
Le tecnologie dell’Intelligenza Artificiale (IA) possono contribuire a migliorare la gestione delle risorse naturali ed essere strumenti efficaci nella lotta al cambiamento climatico? È la domanda che ha mosso un intero Panel presente a Remtech 2025, intitolato “Come l’IA può supportare i procedimenti ambientali” e dedicato – in parte – a comprendere come l’IA può essere utile per la verifica di conformità ambientale, cioè come aiutare chi deve far rispettare le regole, dovendosi districare tra una selva di norme e interpretazioni, non sempre a portata di mano. Fabio Carella di Arpa Lombardia e Giuseppe Sgorbati in rappresentanza di IMPEL (European Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, network di soggetti coinvolti nella predisposizione, implementazione e attuazione della normativa ambientale) hanno provato a fare un primo punto sullo stato dell’arte e sui possibili risvolti futuri, anche alla luce delle prime evidenze del progetto Artic, finanziato dall’Unione europea e nato dalla collaborazione tra IMPEL e ENPE (European Network of Prosecutors for the Environment) – associazione no-profit di respiro internazionale nata con lo scopo di promuovere l’applicazione della normativa penale ambientale supportando l’attività dei procuratori specializzati nella protezione dell’ambiente – insieme al Forum europeo dei giudici per l’ambiente (EU Forum of Judges for the Environment – EUFJE) e la Rete europea di eccellenza nel contrasto alla criminalità ambientale (Envicrimenet).
Il Progetto ARTIC
Progetto che ha lo scopo di condividere le conoscenze per sfruttare al meglio le potenzialità dell’IA per far rispettare le normative ambientali. Il punto di partenza è che questa possa rappresentare uno strumento utile soprattutto per le autorità amministrative e di controllo, impegnate quotidianamente nell’immane lavoro di applicare la corposa normativa ambientale e verificarne il rispetto.
Nell’ambito del progetto l’IA è stata utilizzata per:
- programmare le attività ispettive attraverso la profilazione del rischio;
- potenziare le tecniche di osservazione terrestre per il contrasto delle violazioni in materia ambientale;
- riconoscere eventuali non conformità presenti nei dataset e nei database.
Le potenzialità del Progetto ARTIC
Le potenzialità dell’IA, nel perimetro del progetto Artic, vanno ben oltre l’utilizzo fino ad oggi sperimentato. Nell’ambito del panel “Come l’IA può supportare i procedimenti ambientali” ne sono state citate alcune:
- Monitoraggio continuo delle emissioni;
- Analisi predittiva e manutenzione preventiva;
- Remote sensing e telerilevamento satellitare, ossia l’utilizzo di immagini multispettrali e iperspettrali da satellite (o droni) per ogni esigenza ambientale;
- Gestione automatizzata dei rifiuti e delle sostanza pericolose;
- Analisi di rischio ambientale e scenari “what-if”, ovvero simulazioni basate su reti neurali e modelli di physics-informed AI per valutare gli impatti di incidenti e definire piani di emergenza;
- Compliance reporting automatizzato per redigere report di conformità destinati a enti regolatori;
- Monitoraggio della qualità dell’acqua e del suolo;
- Chatbot e assistenti virtuali per regulatory guidance, ovvero per rispondere a ogni dubbio normativo;
- Digital twins degli impianti, ovvero creazione di un “gemello digitale” degli impianti industriali in cui l’IA simula flussi di energia e di materia, individuando possibili inefficienze o non conformità;
- Valutazione della carbon footprint e offsetting, ovvero software basati su algoritmi di machine learning per calcolare in modo dinamico le emissioni e suggerire interventi di riduzione.
Per poter sfruttare a pieno queste potenzialità, è necessario innanzitutto implementare le conoscenze di base per uno corretto settaggio e gestione dei sistemi di IA, individuando i requisiti professionali, tecnici, organizzativi e di governance necessari. Con questo obiettivo, verrà realizzato un manuale che valorizzi “le best practice già in uso presso le istituzioni aderenti al progetto, con indicazioni di condizioni e modalità per l’eventuale adozione da parte di altre istituzioni”. Un lavoro che comporta anche una ricognizione delle norme che finora hanno regolato l’IA nelle varie legislazioni europee, per definire linee-guida e suggerire modalità di utilizzo dell’IA nella giurisdizione, con particolare riguardo alla compliance ambientale.
L’autoapprendimento
La diffusione delle competenze tra i partner del progetto è l’altro asse portante dell’iniziativa. Si prevede la definizione di “programmi multilivello di alfabetizzazione e formazione e di strumenti rapidi ed efficaci, tra i quali le comunità di pratica e l’autoapprendimento, nel tentativo di stare al passo con la dinamicità della materia”. Saranno organizzati anche “corsi di formazione sui vari aspetti e di addestramento vero e proprio sull’utilizzo di specifici sistemi eventualmente già in uso presso le istituzioni aderenti al progetto in modo da essere diffusi al resto degli interessati”.
Le applicazioni pratiche dell’IA più promettenti
Al momento, le applicazioni di sistemi di IA sulle quali si sta già lavorando nel campo della giurisdizione ambientale sono:
- Analisi di Rischio (Risk Assessment), soprattutto in ottica di prevenzione dei reati ambientali;
- Analisi di dati (Data Analytics), con la finalità di individuare anomalie, correlabili a violazioni e falsificazioni su insiemi di dati complessi;
- Visione Artificiale (Computer Vision), finalizzata all’interpretazione di immagini digitali, per tutti gli scopi per i quali un esame morfologico di “oggetti” può essere rilevante ai fini della protezione ambientale.
Il ruolo dell’UE
L’Unione europea da tempo sta seguendo le evoluzioni sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di rafforzare la ricerca e la capacità industriale e, nel contempo, garantire la sicurezza e i diritti dei cittadini. Per questo ha adottato una Strategia sull’IA finalizzata a garantire uno sviluppo tecnologico antropocentrico e affidabile, attraverso norme e azioni concrete. Nel merito, il piano d’azione si concentra sullo sviluppo di tecnologie di IA che rispondano a criteri di eccellenza e fiducia, che consentano di rafforzare la competitività dell’Europa, salvaguardando e promuovendo nel contempo i nostri valori democratici.