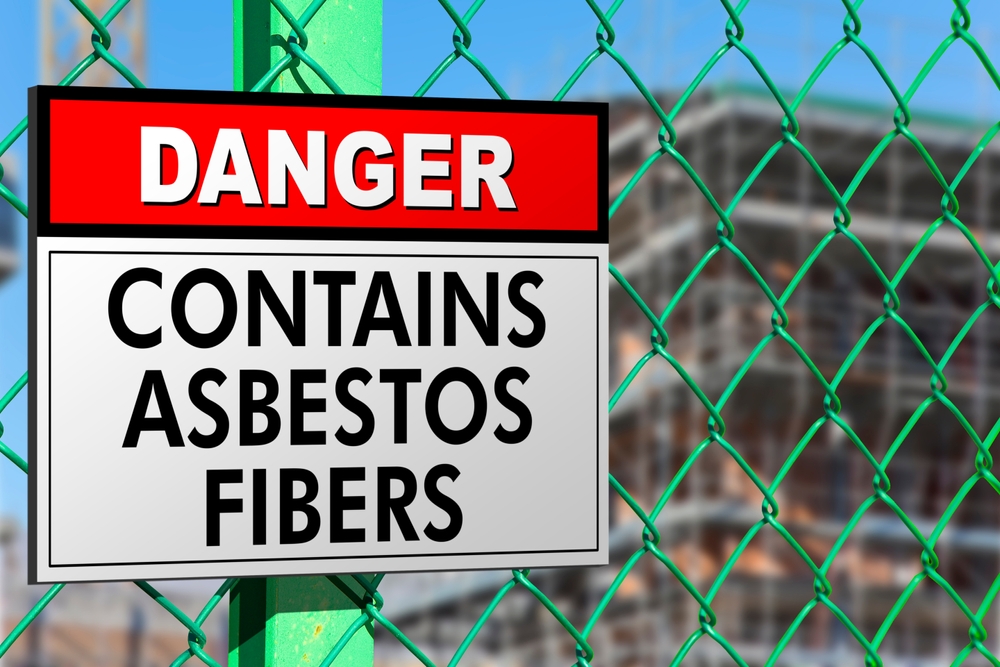Gli orti sociali sono più di semplici appezzamenti di terreno dove coltivare pomodori o basilico. Si tratta di veri e propri laboratori all’aperto di sostenibilità urbana; inclusione sociale ed educazione ambientale. Sono nati come misura di sussistenza, ma oggi rappresentano una risposta concreta ai bisogni di verde, socialità e cibo sano, all’interno del denso tessuto urbano.
I giardini di comunità rigenerano zone urbane inutilizzate – spesso aree degradate o abbandonate – trasformandole in centri nevralgici della vita comunitaria. Il modello si basa sulla cessione temporanea di piccoli lotti (solitamente compresi tra i 20 e i 50 metri quadrati) a cittadini, associazioni o scuole. Questi li coltivano secondo regole condivise. Il risultato non è solo la produzione alimentare a chilometro zero, ma anche un profondo impatto su benessere psico-fisico e coesione sociale. Gli orti sociali sono un esempio perfetto di come la gestione condivisa delle risorse possa generare un valore, ecologico e umano, che supera di gran lunga quello del semplice, seppur prezioso, prodotto della terra.
Non solo un orto: definizione e valori dell’agricoltura sociale
Un orto sociale si distingue da un comune orto urbano individuale per le sue finalità, che vanno oltre la semplice produzione alimentare. L’obiettivo primario è la rigenerazione sociale: favorire l’inclusione, creare legami tra le persone, offrire opportunità terapeutiche e didattiche.
A differenza degli orti urbani privati, per così dire, quelli sociali sono basati sulla condivisione del lavoro, degli spazi comuni, dai depositi alle aree di compostaggio, e, talvolta, anche di parte del raccolto. È quanto accade in quelle realtà che collaborano con le mense per i poveri locali o con le banche alimentari.
Benefici misurabili: dal benessere psicofisico alla sicurezza del quartiere
I benefici generati dagli orti sociali sono considerevoli e misurabili. Essi toccano sia la sfera individuale sia quella collettiva.
- Il contatto con la terra, l’attività fisica leggera e l’esposizione alla luce solare riducono lo stress e migliorano l’umore. Molti orti vengono utilizzati in progetti di ortoterapia rivolti a persone con disabilità o problemi di salute mentale, al fine di consolidarne il benessere psicofisico.
- Gli orti sociali diventano luoghi di incontro intergenerazionale e interculturale, rompendo l’isolamento tipico delle grandi città e facendosi strumenti di inclusione sociale. Gli anziani possono trasmettere le loro competenze agricole ai più giovani e persone di diversi agi e origini linguistiche imparano a lavorare fianco a fianco.
- La cura di uno spazio comune aumenta esponenzialmente il senso di appartenenza, così come il controllo sociale informale. Un’area verde curata e frequentata scoraggerà gli atti vandalici e terrà più lontano il degrado. Studi internazionali dimostrano che la presenza di orti comunitari può ridurre il vandalismo in un quartiere fino al 30%. La costante presenza di cittadini attivi funge da deterrente e aumenta la sicurezza.
- La creazione di aree verdi, gestite con metodi biologici e che prevedano l’installazione di bee-house e/o la coltivazione di specie autoctone, funge da vero e proprio corridoio ecologico, aumentando la biodiversità vegetale e animale all’interno del contesto urbano.
I modelli di gestione: tre vie per far nascere un orto sociale
Avviare un orto sociale richiede dapprima l’individuazione di un’area idonea. Tipicamente, ci si serve di un terreno comunale inutilizzato, o dismesso. Occorre poi un chiaro modello di gestione, che definisca chi può accedere, come partecipare al bando e quali siano le sue regole.
Il modello comunale: l’assegnazione degli appezzamenti
Questo modello è il più classico e diffuso. Solitamente, sebbene non necessariamente, si rivolge ad anziani o pensionati. In altre occasioni, il municipio può aprire l’opportunità a ogni cittadino residente nel quartiere. Il comune, in genere, mantiene la proprietà e la gestione generale dell’area, ma assegna i singoli appezzamenti in concessione temporanea (solitamente fino a 3 o 5 anni), tramite bando pubblico. I coltivatori sono responsabili del proprio lotto. Tutte le aree comuni, invece, sono gestite dal municipio.
Sebbene offra una limitata flessibilità associativa e il suo valore sociale, nonostante il nome, venga meno, si tratta comunque di un ottimo strumento, capace di garantire un’attività all’aperto alla popolazione più anziana.
Il modello associativo negli orti sociali: un patto di collaborazione
In questo modello alternativo, non è il comune, bensì un’associazione, un comitato di quartiere o un gruppo informale, a prendere in gestione un’area pubblica abbandonata o sottoutilizzata. Lo strumento attraverso il quale lo fa, spesso, è quello del Patto di Collaborazione. L’associazione definisce il regolamento interno, assegna i lotti e si occupa integralmente della manutenzione, della programmazione e delle attività collaterali.
Si tratta del modello più diffuso per la rigenerazione urbana dal basso, poiché il senso di appartenenza e la partecipazione attiva sono molto elevati. La rete nazionale degli orti urbani di Campagna Amica offre tutto il supporto necessario per avviare questo tipo di progetti.
Il modello ibrido: la partnership tra pubblico e privato
Questo terzo modello coinvolge, molto spesso, cooperative sociali, ONLUS o enti che gestiscono orti su terreni comunali, integrando la produzione con finalità lavorative o terapeutiche. L’obiettivo primario non è soltanto quello di coltivare e godere del raccolto, come avviene negli altri due modelli, ma offrire percorsi di inserimento lavorativo e riabilitazione per persone fragili quali disoccupati di lunga durata, soggetti con disabilità o ex detenuti. In questo caso, l’attività agricola diventa un vero e proprio servizio di welfare.
I prodotti generati dalle operazioni agricole vengono spesso venduti, o utilizzati in servizi di ristorazione sociale. Ciò crea un circolo economico virtuoso e autosufficiente, dovuto a una vera e propria prestazione lavorativa di soggetti che, altrimenti, faticherebbero a inserirsi nel mondo del lavoro.
Guida pratica: come avviare un orto sociale nel proprio quartiere
| FASE | AZIONI CHIAVE | ATTORI COINVOLTI | STRUMENTI E DOCUMENTI NECESSARI |
| 1. Ideazione | Definizione degli obiettivi, che possono essere educativi, terapeutici e/o sociali, e formazione del gruppo promotore. | Cittadini, associazioni, scuole, comitati di quartiere… | È sufficiente una bozza di progetto. |
| 2. Mappatura | Identificazione di un’area idonea, che sia pubblica o privata, preferibilmente in disuso o sottoutilizzata. | Ufficio comunale all’Urbanistica e al Patrimonio. | Mappe catastali e strumenti di pianificazione urbana. |
| 3. Progettazione | Disegno e ideazione degli spazi: orti individuali; aree comuni; compostiera; deposito attrezzi… | Agronomi, architetti e membri della comunità. | Planimetria dettagliata del progetto. |
| 4. Burocrazia | Presentazione del progetto al Comune e stipula di un Patto di Collaborazione o convenzione. | Assessore al Verde o alla Partecipazione, uffici legali. | Statuto dell’associazione, regolamento dell’orto, Patto di Collaborazione. |
| 5. Realizzazione | Bonifica dell’area, preparazione del terreno, installazione delle recinzioni e collocazione dell’impianto idrico. | Volontari della comunità, sponsor tecnici, comune. | Piano dei lavori e budget dettagliato. |
Il Patto di Collaborazione: uno strumento per cittadini attivi
Per poter avviare orti sociali su terreno pubblico, così come per poter intraprendere numerose altre attività, l’aspetto legale e la collaborazione con l’amministrazione sono due aspetti di importanza cruciale. Il patto cui abbiamo accennato alcuni paragrafi fa è lo strumento concreto attraverso il quale si può raggiungere questo obiettivo. Si tratta di un meccanismo giuridico nato dal principio noto come di sussidiarietà orizzontale, introdotto dall’Articolo 118 della Costituzione italiana. Questo riconosce il diritto dei cittadini, singoli o riuniti in associazione, di svolgere attività di interesse generale, quando le istituzioni non riescano a intervenire in modo efficace o, più semplicemente, al fine di favorire la partecipazione attiva.
Il Patto di Collaborazione è promosso e studiato, in Italia, dal laboratorio per la sussidiarietà (Labsus). Non è che un accordo tra comune e cittadini (o associazione, come si è scritto) per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani. Non è una richiesta, dal momento che non si domanda al municipio di attivarsi, bensì gli si propone di collaborare in qualcosa. Il comune fornirà terreno, supporto tecnico e, magari, accesso all’acqua. Mentre l’associazione si impegnerà a ripulire, coltivare e gestire lo spazio secondo un piano condiviso e un regolamento. Di fatto, si attiva una partnership bilaterale.
Questo strumento conferisce una veste legale e duratura al progetto di orto sociale su area pubblica. Protegge gli sforzi della comunità e garantisce che il terreno rimanga disponibile per la sua funzione rigenerativa a lungo termine, trasformando la cura del verde in un atto di co-amministrazione cittadina. Gli orti sociali ci dimostrano che la vera sostenibilità urbana si realizza quando l’ecologia incontra la comunità. Non si tratta solo di coltivare cibo, ma di innaffiare e veder crescere benessere e rinnovato senso civico; un piccolo lotto alla volta.