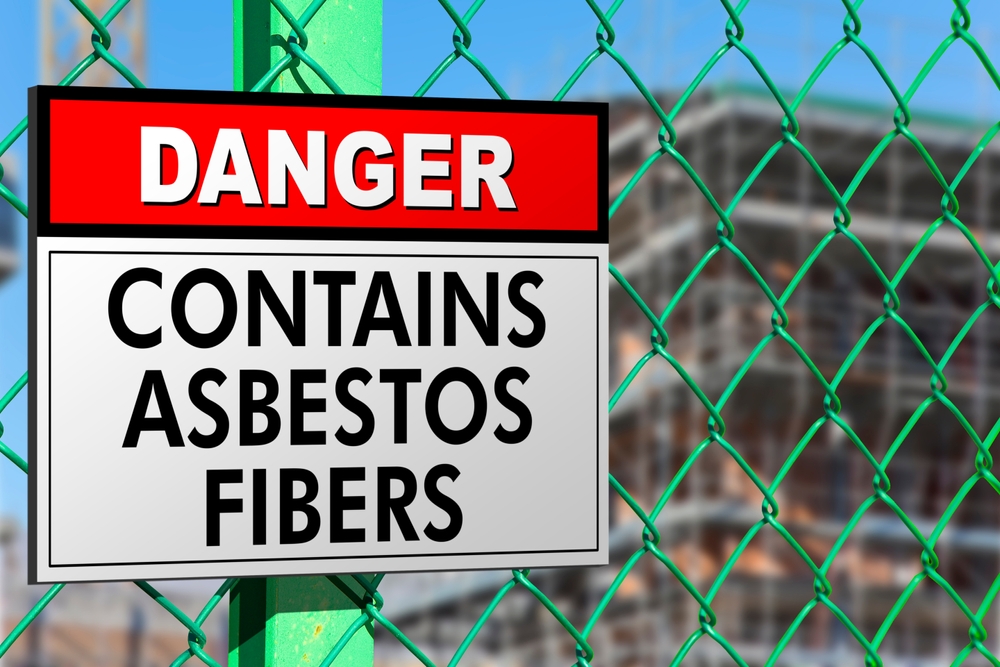Quando il caldo non viene solo dal cielo: l’asfalto rovente e le superfici urbane amplificano le ondate di calore, trasformando le città in trappole termiche.
In estate, camminare su una strada asfaltata può trasformarsi in un’esperienza estrema: le superfici nere delle città italiane arrivano a toccare 60–65 °C in piena estate, contribuendo in modo significativo all’effetto isola di calore. È l’asfalto, con il suo bassissimo albedo e l’elevata capacità di assorbire e rilasciare calore, a giocare il ruolo del principale colpevole.
In un contesto urbano densamente costruito, dove la radiazione solare viene intrappolata da materiali scuri e impermeabili, il microclima urbano si trasforma, aggravando il discomfort termico e aumentando la domanda energetica per il raffrescamento. In alcune città, come Milano, Roma o Palermo, le temperature al suolo superano di diversi gradi quelle registrate in aree verdi, con differenze che arrivano fino a +4 °C. Ecco quindi un confronto tra cinque metropoli italiane che mostra quanto l’asfalto sia non solo una superficie, ma un vero motore termico urbano, e quanto sia urgente ripensare materiali, colori, ombra e permeabilità per città più vivibili.
Perché l’asfalto si scalda così tanto
Camminare su una strada d’asfalto ad agosto è un’esperienza che coinvolge tutto il corpo: non è solo il sole diretto a far sudare, ma è il calore che si irradia dal basso a rendere l’aria irrespirabile. La superficie stradale in asfalto può infatti raggiungere facilmente 60–65 °C, con picchi fino a 85 °C in condizioni di massima insolazione. Questo comportamento estremo dipende dalle proprietà fisiche del materiale: l’asfalto ha un colore molto scuro, una riflettanza solare (albedo) bassissima – intorno allo 0,05 per l’asfalto fresco e allo 0,10 per quello usurato – e una elevata capacità termica, che gli consente di immagazzinare e rilasciare lentamente il calore durante la notte. Anche la sua emissività è elevata (oltre 0,90), il che significa che, pur rilasciando energia termica verso l’esterno, contribuisce a riscaldare l’ambiente urbano circostante, peggiorando il microclima.
Il confronto con altre superfici urbane è netto: un prato verde, ad esempio, ha un’albedo di circa 0,26 e utilizza parte della radiazione solare per alimentare l’evapotraspirazione, un processo di raffrescamento naturale che abbassa sensibilmente la temperatura dell’aria. Le pavimentazioni chiare o riflettenti (i cosiddetti materiali riflettenti o cool pavements) possono invece ridurre la temperatura superficiale fino a 30 °C in meno rispetto all’asfalto.
Queste dinamiche concorrono tutte al fenomeno dell’Urban Heat Island (UHI), ovvero l’effetto isola di calore urbana: le città diventano significativamente più calde rispetto alle zone rurali circostanti, con differenze di temperatura dell’aria anche superiori a 4 °C. La scelta dei materiali per le superfici urbane non è dunque neutra: in un clima sempre più caldo, diventa strategica. Anche perché – dato spesso ignorato – a che temperatura si scioglie l’asfalto? A partire da 50–60 °C, la miscela comincia a rammollirsi, e oltre gli 80 °C la struttura molecolare del bitume può degradarsi, con conseguenze anche per la sicurezza stradale.
Tabella – Confronto tra asfalto e altre superfici urbane
Fonti: Romano asfalti, ISAC, Scuola di Ingegneria Unipi
| Materiale | Albedo (%) | Indice di Riflettanza Solare (SRI) | Temp. superficiale in agosto (°C) | Note principali |
| Asfalto nuovo (fresco) | 5 | 6 | >65 | Assorbe il 95% della radiazione solare |
| Asfalto invecchiato | 10–15 | <20 | 60–80 | Peggiora col tempo, degrado del legante bituminoso |
| Calcestruzzo chiaro | 22–52 | 19–52 | 45–55 | Migliore riflettanza, ma ancora superficie minerale |
| Sanpietrino / pietra scura | 10–20 | <25 | 55–65 | Contribuisce all’UHI nei centri storici |
| Erba verde | 26 | ~25 | 30–35 | Raffresca attivamente grazie all’evapotraspirazione |
| Cool pavement (esempio tipo) | >60 | >78 | 35–45 | Materiale riflettente, ideale per mitigazione |
5 città italiane a confronto: chi scotta di più?

Per valutare quanto l’asfalto contribuisca al surriscaldamento urbano in estate è fondamentale osservare non solo le temperature dell’aria, ma soprattutto le temperature superficiali delle città, misurate attraverso rilevazioni satellitari. Le superfici asfaltate, in particolare, possono variare molto in base a fattori come latitudine, densità edilizia, presenza di verde urbano e morfologia del tessuto urbano.
Per questo confronto sono state selezionate cinque città italiane rappresentative di contesti molto diversi:
- Milano, città del Nord con clima continentale e altissima densità costruttiva;
- Roma, metropoli estesa e complessa, fortemente trafficata;
- Napoli, con la sua struttura urbana duale tra centro storico ombreggiato e periferie arroventate;
- Bologna, esempio tipico di centro compatto con “effetto canyon”;
- Palermo, città mediterranea soggetta a fortissimo irraggiamento solare e con scarsa ombreggiatura.
Queste città sono state analizzate in base a tre parametri fondamentali:
- Temperature superficiali medie nel mese di agosto, indicative dello stress termico urbano;
- Superficie asfaltata e suolo impermeabile pro capite, come misura indiretta della capacità di accumulo di calore;
- Percentuale e distribuzione di aree verdi, che rappresentano il principale elemento di mitigazione dell’urban heat.
Lo studio si basa su dati raccolti da ricerche scientifiche e report di importanti agenzie ambientali come ISPRA e ARPA, con un focus particolare su una recente indagine guidata dall’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe), in collaborazione con ISPRA. Questa ricerca ha preso in esame il fenomeno delle isole di calore urbane superficiali (Surface Urban Heat Island – SUHI) in tutti i capoluoghi di regione italiani, monitorando i mesi estivi – da giugno ad agosto – nell’arco di dieci anni, dal 2013 al 2023, grazie all’uso di dati satellitari.
I risultati mostrano che questo fenomeno è presente ovunque, ma con intensità variabile: si registrano differenze di temperatura tra le zone urbane e quelle rurali particolarmente elevate a L’Aquila (+5,6 °C), Genova (+5,2 °C) e Trieste (+4,8 °C). Se invece guardiamo alle temperature superficiali assolute, le città interne come Firenze (44,1 °C) e Bologna (44,0 °C) spiccano per i valori medi estivi più alti. Esaminiamo quindi i dati e le caratteristiche specifiche di ciascuna città per capire chi scotta di più e perché.
Milano: calore urbano e superficie asfaltata elevata
Milano rappresenta un esempio significativo di città continentale densamente urbanizzata nella Pianura Padana, dove l’estate è caratterizzata da un microclima fortemente influenzato dall’elevato consumo di suolo e dall’impermeabilizzazione diffusa. Le vaste aree industriali dismesse, i grandi parcheggi e la fitta rete stradale contribuiscono a ridurre la ventilazione naturale, intrappolando calore e inquinanti vicino al suolo e intensificando l’effetto isola di calore. I dati satellitari, tra cui quelli del progetto europeo Life METRO Adapt, mostrano che durante le ondate di calore la temperatura nelle zone urbane può superare di oltre 5 °C quella delle aree rurali circostanti.
L’estate 2023 ha registrato un record con 33 °C di media giornaliera a Milano Brera, il valore più alto dal 1763. Sebbene Milano abbia una percentuale relativamente alta di verde pubblico (12,6%), la disponibilità di spazi verdi pro capite è tra le più basse d’Italia, appena 16,6 m² per abitante, a causa dell’alta densità abitativa. La cementificazione continua a crescere: solo nel 2023 sono stati consumati 780 ettari in Lombardia. Per mitigare questi effetti, il Comune ha avviato iniziative come “Piazze Aperte”, che trasforma spazi pubblici sottoutilizzati in aree pedonali con pavimentazioni riflettenti e nuove piante, e progetti di forestazione urbana, inclusi ombreggiamenti sperimentali e la creazione di “Oasi Scolastiche” per aumentare il verde e la resilienza climatica.
Roma: traffico e superfici radianti
Roma è una città caratterizzata da un territorio molto vasto, che comprende sia ampie aree urbane sia zone di agro romano, un traffico veicolare tra i più intensi d’Europa e un ricco patrimonio storico fatto di pavimentazioni in sanpietrini e soprattutto marmi chiari. Questi materiali, pur essendo simboli preziosi della città, hanno un basso potere riflettente e un’elevata capacità di accumulare calore, soprattutto se privi di ombra, contribuendo così in modo significativo all’effetto isola di calore, specialmente nelle piazze e strade esposte.
Durante le ondate di calore estive, molte zone registrano temperature notturne sopra i 27-28 °C, con un riscaldamento urbano medio intorno ai +2 °C rispetto al periodo 1971-2000. Nonostante la percentuale di verde pubblico sul totale comunale sia bassa (3,5%), l’estensione del territorio fa sì che la dotazione di verde pro capite sia tra le più alte d’Italia, con circa 153 m² per abitante. I grandi parchi e le ville storiche coprono quasi il 43% del verde urbano. Il consumo di suolo resta alto, con 71 ettari consumati solo nel 2023. Per contrastare questi effetti, Roma sta puntando su piani di forestazione finanziati dal PNRR e su una strategia di adattamento climatico basata su approfondite analisi scientifiche, per orientare interventi mirati di verde urbano e depavimentazione nelle aree più vulnerabili.
Napoli: il caso del centro storico e la brezza marina
Napoli si distingue per una morfologia urbana molto variegata che crea microclimi differenti: il centro storico, con i suoi vicoli stretti e gli edifici alti, crea un “effetto canyon” che offre ombra quasi costante e, insieme alla brezza marina, mitiga il caldo. Al contrario, le periferie, spesso cresciute in modo disordinato, sono caratterizzate da ampie superfici asfaltate, scarsa vegetazione e alta densità edilizia, condizioni che amplificano l’effetto “grill” estivo.
Misurazioni dirette mostrano che nelle piazze centrali le superfici possono raggiungere punte di 50-60 °C nelle ore più calde, mentre l’isola di calore fa sì che le temperature d’aria in centro siano 1-2 °C più elevate rispetto alle zone suburbane. Il verde urbano pro capite è di circa 42 m² per abitante, con parchi che coprono poco meno del 23% del totale. Tuttavia, la Campania resta una delle regioni con il più alto consumo di suolo, con 643 ettari persi nel 2023. Per affrontare l’emergenza climatica, Napoli attiva ogni estate un “Piano Caldo” rivolto alle persone più vulnerabili, e partecipa al progetto europeo SPOTTED, che utilizza dati satellitari per monitorare l’isola di calore, lo stato della vegetazione e la vulnerabilità della popolazione, fornendo così strumenti avanzati per la pianificazione urbana e la gestione del verde.
Bologna: effetto canyon urbano nel centro compatto
Bologna, con il suo compatto centro storico medievale, è un chiaro esempio di “effetto canyon” urbano: le strette vie e i lunghi portici proteggono dal sole diretto, ma favoriscono l’accumulo di calore di giorno e ne impediscono la dispersione notturna a causa della scarsa ventilazione. Le pavimentazioni in pietra e asfalto scuro, a basso albedo, aumentano ulteriormente il surriscaldamento, con temperature superficiali estive che possono raggiungere i 44 °C.
Bologna ha una buona dotazione di verde urbano (50 m² pro capite), con quasi la metà rappresentata da grandi parchi, ma l’Emilia-Romagna è una delle regioni con il più alto consumo di suolo in Italia (+815 ettari nel 2023). Per contrastare il caldo, la città ha attuato il piano di adattamento BlueAp, che prevede migliaia di nuovi alberi, orti urbani e tetti verdi, e ha lanciato interventi tattici come l’installazione temporanea di 100 grandi alberi in vaso nelle piazze principali per creare ombra immediata.
Palermo: tra irraggiamento estremo e scarsa vegetazione
Palermo si trova in una posizione geografica che la espone a un irraggiamento solare molto intenso e prolungato durante l’estate. La scarsità di vegetazione e ombra nel centro urbano, unita a superfici assorbenti come asfalto e cemento, porta a temperature superficiali estremamente elevate, con punte fino a 60 °C in alcune piazze. L’isola di calore è accentuata nelle periferie, dove si trovano più asfalto e meno verde. La dotazione di verde pro capite è di circa 82 m², ma gran parte è costituita da piccole aiuole e spartitraffico, meno efficaci nella mitigazione.
La Sicilia registra un alto consumo di suolo (+521 ettari nel 2023). A Palermo le strategie si concentrano soprattutto sulla gestione delle emergenze climatiche, con un Piano Caldo che attiva supporti per le fasce più vulnerabili, e un PAESC che riconosce il problema, ma con azioni di mitigazione fisica ancora poco sviluppate rispetto ad altre città.
Tabella – 5 città italiane a confronto, dati indicativi estivi
| Città | Intensità SUHI Media Estiva (°C vs rurale) | Temp. Superficiale e Media Centro Urbano (°C) | % Suolo Consumato (Provincia, 2023) | m² Verde Urbano pro capite | Principale Fattore Morfologico/Climatico | Principale Strategia di Mitigazione Adottata |
| Milano | Fino a +5°C (notturno) | Elevata (record 33°C media giornaliera) | 31.4% | 16.6 | Alta densità, bassa ventilazione, suolo impermeabile | Urbanistica tattica (Piazze Aperte), strategie di ombreggiamento |
| Roma | +2°C (anomalia media) (picchi notturni >27°C) | Elevata | 9.9% | 152.7 | Vasta estensione, traffico intenso, superfici minerali | Forestazione urbana su larga scala (PNRR) |
| Napoli | +1-2°C (centro vs periferia) | Molto elevata (picchi superficiali >50°C) | 15.6% | 41.9 | Morfologia duale: centro storico ombreggiato, periferie esposte | Monitoraggio satellitare (SPOTTED), piani di assistenza |
| Bologna | +1.3°C (media) | 44.0°C | 14.5% | 50.0 | Effetto canyon nel centro storico compatto | Piano di Adattamento (BlueAp), interventi tattici (alberi in vaso) |
| Palermo | < +1°C (anomalia media) | Molto elevata (record aria 45.8°C) | 8.8% | 81.5 | Intenso irraggiamento solare, scarsa vegetazione urbana | Piani di Protezione Civile per emergenza calore |
Effetti sulla salute e sulla vivibilità urbana
Il surriscaldamento delle città non è solo una questione ambientale: ha impatti diretti su salute, qualità della vita e sistemi energetici. Le alte temperature superficiali amplificano i rischi per le fasce più fragili della popolazione, aumentano il consumo energetico e peggiorano la qualità dell’aria e delle acque.
Rischi per la salute: il caldo estremo mette in pericolo la salute pubblica, con picchi di mortalità e ricoveri, in particolare per anziani, persone fragili e lavoratori esposti all’esterno. Oltre ai colpi di calore, l’aumento delle temperature aggrava patologie croniche (cuore, polmoni, reni) e mette sotto stress chi vive in case poco isolate o senza condizionamento. Secondo i dati di Arpa Lazio, a Roma, ad esempio, la mortalità totale durante le ondate di calore può salire fino al +37%.
Carico energetico e costi: l’ondata di calore spinge all’uso massiccio di climatizzatori, sovraccaricando la rete elettrica e alzando i costi in bolletta. Ogni grado in più può ridurre fino all’80% la produttività in lavori fisici intensi. Inoltre, la perdita di suolo permeabile ha già causato in Italia danni stimati tra 7 e 9 miliardi di euro per la perdita di servizi ecosistemici.
Qualità ambientale: il caldo urbano alimenta reazioni chimiche che aumentano smog e ozono, aggravando i problemi respiratori. Anche l’acqua piovana, scorrendo su superfici bollenti, si trasforma in un veicolo di inquinanti: riversata nei fiumi, può provocare shock termici per la fauna acquatica. Il risultato è un ciclo vizioso: più calore, più condizionamento, più inquinamento – e un ambiente sempre meno vivibile.
Come raffreddare le superfici urbane
Soluzioni tecniche:
- Utilizzo di “cool materials”: pavimentazioni e coperture realizzate con materiali ad alta riflettanza solare (albedo elevato) e alta emissività termica. Possono ridurre la temperatura superficiale fino a 30 °C rispetto a materiali tradizionali. Esempi includono asfalti chiari, cementi riflettenti e rivestimenti speciali.
- Ombreggiamento con alberature e pensiline verdi: gli alberi combinano ombra e raffrescamento tramite evapotraspirazione. Un aumento del 5% della copertura arborea può abbassare la temperatura superficiale media urbana di oltre 0,5 °C. Come ricorda la SNPA, fondamentale è il rispetto della regola del “3-30-300”: vedere 3 alberi da casa, vivere in un quartiere con il 30% di copertura arborea e avere uno spazio verde entro 300 m.
- Depavimentazione e suolo permeabile: rimuovere superfici asfaltate o cementate non essenziali (es. parcheggi in eccesso) per ripristinare il suolo naturale o installare pavimentazioni drenanti. Si favorisce il raffrescamento evaporativo e la gestione sostenibile delle acque piovane.
- Applicazione di vernici riflettenti (casi studio: Los Angeles, Tel Aviv):
Los Angeles: riduzione della temperatura stradale fino a 5,6 °C e dell’aria fino a 1,9 °C in condizioni estreme. Tuttavia, è stato rilevato un potenziale aumento del disagio termico per i pedoni a causa della radiazione riflessa.
Tel Aviv: l’uso combinato di pavimentazioni chiare e alberature, simulato con modelli microclimatici, ha mostrato una significativa riduzione della temperatura media radiante (MRT), migliorando il comfort umano.
Le esperienze dimostrano che l’efficacia dei cool materials cresce se integrati con l’ombreggiamento naturale.
In sintesi
Le città italiane bollono sotto i nostri piedi: raffreddare il suolo significa raffreddare la vita urbana. Perché dove l’asfalto cuoce, la qualità della vita evapora.