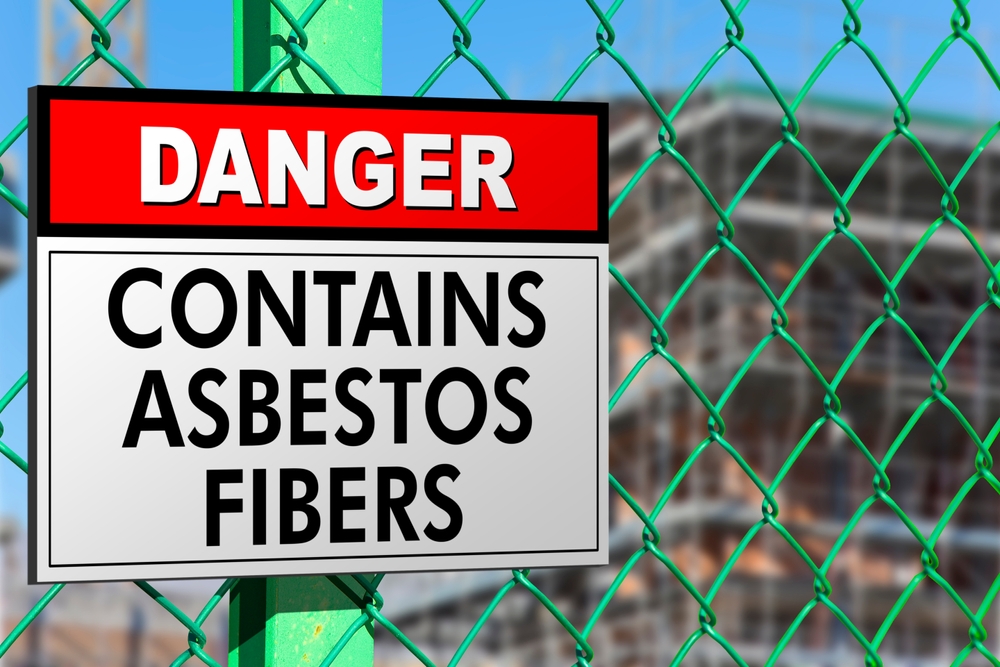Quanto vale davvero una tonnellata di CO₂? Un indicatore chiave per capire il costo del clima e orientare le scelte del futuro.
Quanto dovrebbe costare una tonnellata di CO₂ per riflettere davvero il suo impatto sul clima e sulla società? È questa la domanda a cui cerca di rispondere il concetto di shadow price of carbon, ovvero prezzo ombra del carbonio. Si tratta di un indicatore sempre più utilizzato a livello europeo – e non solo – per stimare il vero costo delle emissioni di gas serra. Va oltre le fluttuazioni del mercato e considera i costi esterni ambientali, come i danni alla salute, alla biodiversità e agli ecosistemi.
In pratica, il prezzo ombra misura quanto dovrebbe essere idealmente il prezzo di una tonnellata di CO₂ affinché politiche, investimenti e progetti siano coerenti con gli obiettivi climatici. Secondo le raccomandazioni europee, per centrare i target Net Zero, questo valore dovrebbe collocarsi tra 80 e 300 euro per tonnellata entro il 2030. Tuttavia, il mercato reale del carbon pricing in Europa, rappresentato principalmente dall’Emission Trading System (ETS), si muove ancora su cifre più basse, pur mostrando una crescita negli ultimi anni.
Comprendere questa differenza tra prezzo reale e prezzo ombra è cruciale. È qui che si gioca la coerenza tra le strategie di transizione ecologica e le scelte economiche concrete. Scopriamo insieme in che modo.
Cos’è lo shadow price of carbon
Per capire cos’è lo shadow price of carbon bisogna partire da una distinzione fondamentale. Non si tratta del prezzo effettivo pagato sul mercato per emettere CO₂, ma di un valore ipotetico, calcolato ex ante, che rappresenta il costo ottimale di una tonnellata di emissioni per raggiungere determinati obiettivi climatici.
In termini semplici, lo shadow price of carbon è un prezzo teorico che riflette quanto dovremmo essere disposti a pagare oggi per evitare gli impatti futuri di una tonnellata di CO₂ sull’ambiente e sulla società. Questo valore serve a orientare decisioni di investimento, valutare progetti pubblici e privati e misurare i costi esterni ambientali che normalmente non vengono contabilizzati nei mercati.
Come si legge nella guida The Shadow Price of Carbon in Economic Analysis di World Bank, lo shadow price si distingue da altri meccanismi di prezzo del carbonio:
- Il prezzo di mercato dell’ETS europeo è determinato dall’incontro tra domanda e offerta di quote di emissione scambiabili tra industrie. È reale, ma soggetto a volatilità e influenzato da fattori geopolitici ed economici. Nel 2023 ha toccato i 100 euro/t, ma è poi sceso a circa 60 euro/t a inizio 2024.
- La carbon tax è un’imposta diretta sulle emissioni, stabilita dallo Stato. È più stabile dell’ETS, ma spesso politicamente più difficile da attuare.
- Il Social Cost of Carbon (SCC) è un altro approccio teorico che stima i danni monetari totali causati da una tonnellata di CO₂ emessa oggi. A differenza dello shadow price, che è costruito per essere coerente con un obiettivo di decarbonizzazione (es. +1,5 °C), l’SCC si concentra sulle conseguenze economiche a lungo termine, ed è soggetto a grandi incertezze.
Lo shadow price of carbon è utilizzato da diverse istituzioni internazionali e governi come strumento guida per integrare le considerazioni climatiche nelle valutazioni economiche:
- Commissione Europea: fissa valori di riferimento per i prezzi del carbonio nei suoi strumenti di valutazione costi-benefici, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. I range stimati sono tra 80 e 300 €/t CO₂ al 2030, a seconda dello scenario considerato.
- World Bank: nel suo 2024 Guidance Note raccomanda l’uso dello shadow price nei progetti finanziati, con traiettorie che vanno da 40 a 100 USD/t nel 2030 e fino a 156 USD/t nel 2050, per riflettere le politiche compatibili con l’Accordo di Parigi.
- IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e BEIS UK (Dipartimento britannico per l’Energia) includono nei loro modelli shadow prices per confrontare scenari di policy e stimare i costi della transizione ecologica.
Il prezzo ombra del carbonio diventa così uno strumento chiave per valutare l’impatto ambientale e sociale di progetti pubblici e privati, orientare le politiche fiscali e indirizzare gli investimenti verso modelli a basse emissioni. In altre parole, è il cuore di una transizione ecologica “valutata”, dove ogni tonnellata di CO₂ ha un prezzo che riflette il suo vero peso per la collettività.
Come varia il valore del carbonio in Europa

Il prezzo del carbonio in Europa segue due traiettorie parallele ma molto diverse: da un lato c’è il prezzo reale del mercato ETS, influenzato da domanda, offerta, crisi geopolitiche e dinamiche industriali; dall’altro c’è lo shadow price, cioè il valore teorico stimato dalle istituzioni europee per orientare politiche climatiche coerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione.
La tabella seguente mette a confronto l’evoluzione del prezzo effettivo dell’ETS con il range raccomandato di shadow price of carbon per ciascun anno. La colonna “Gap minimo” indica la distanza tra il prezzo di mercato e il valore minimo dello shadow price stimato per lo stesso anno. È un indicatore chiave per capire quanto il mercato stia sottovalutando i costi esterni ambientali legati alle emissioni di CO₂.
Tabella – Prezzo CO₂: ETS vs shadow price
| Anno | ETS reale (€/t) | Shadow price (range UE) | Gap minimo |
| 2020 | 25 | 90–150 | −65 |
| 2023 | 85 | 120–300 | −35 |
| 2024 | 95 | 150–350 | −55 |
Perché è importante per le politiche ambientali
Lo shadow price of carbon sta assumendo un ruolo centrale nella definizione e valutazione delle politiche ambientali, sia a livello europeo che internazionale. Non si tratta solo di un parametro tecnico, ma di uno strumento strategico per orientare scelte pubbliche e private verso modelli a basse emissioni.
Uno dei principali usi dello shadow price è la valutazione economica di progetti carbon intensive. Quando si analizzano grandi investimenti in infrastrutture, trasporti, energia o industria, l’inclusione di un prezzo ombra per la CO₂ consente di tener conto dei costi esterni ambientali che il mercato spesso ignora. L’applicazione dello shadow price può ribaltare l’esito di un’analisi costi-benefici: un progetto apparentemente conveniente può risultare non sostenibile se si considera il costo sociale delle emissioni, mentre un’opzione più green può diventare la più vantaggiosa.
Questo approccio è sempre più adottato anche nei criteri di finanziamento pubblico. A livello europeo, la Commissione utilizza valori di shadow price per stimare l’impatto climatico degli investimenti e orientare le risorse del PNRR, dei fondi strutturali e della BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Progetti che non superano le soglie minime di compatibilità climatica, misurate anche in termini di shadow price, rischiano di non essere finanziati o di ottenere meno supporto economico.
Infine, il prezzo ombra del carbonio sta entrando anche nel mondo della rendicontazione aziendale, in particolare nei report ESG (Environmental, Social and Governance). Sempre più aziende utilizzano internamente valori di shadow carbon pricing per simulare scenari di rischio legati alla transizione ecologica, stimare il costo futuro delle emissioni e allineare i propri investimenti a strategie Net Zero. Questo approccio non solo migliora la trasparenza, ma fornisce un benchmark utile per orientare l’intero settore industriale verso modelli a basse emissioni.
How do carbon markets work?
Cosa comporta per cittadini e territori
L’adozione dello shadow price of carbon non ha impatti solo a livello tecnico o istituzionale. Le sue conseguenze si estendono direttamente a cittadini, imprese locali e pubbliche amministrazioni e influenzano il modo in cui si progetta, si costruisce e si vive nei territori.
Uno dei primi effetti è il rischio di una “carbon bubble”, cioè la possibilità che investimenti in progetti ad alte emissioni diventino improvvisamente non redditizi. Quando si iniziano a considerare i costi ambientali reali delle emissioni, infrastrutture o impianti basati su combustibili fossili possono perdere valore o essere esclusi dai finanziamenti pubblici. Questo impone una riflessione urgente su quali progetti avviare oggi per evitare di ritrovarsi domani con “asset bloccati” e danni economici per comunità e territori.
D’altro canto, l’uso dello shadow price incentiva maggiori investimenti in soluzioni sostenibili, come l’efficienza energetica degli edifici, la mobilità elettrica e collettiva, la bioedilizia e le energie rinnovabili locali. Se questi progetti vengono valutati anche in termini di emissioni evitate, risultano spesso più vantaggiosi rispetto alle alternative tradizionali, aprendo nuove opportunità per l’economia locale, l’occupazione e la qualità della vita.
Infine, anche le pubbliche amministrazioni sono direttamente coinvolte: l’integrazione dello shadow price diventa un criterio rilevante nelle gare pubbliche, nella valutazione dei progetti territoriali, nella pianificazione urbanistica e nella gestione delle risorse ambientali. I Comuni, le Regioni e le stazioni appaltanti devono quindi sviluppare competenze nuove per valutare l’impatto climatico degli investimenti pubblici, evitando di finanziare opere che, pur essendo formalmente regolari, risultano incoerenti con gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine.
In sintesi
Ogni euro in più sul prezzo del carbonio è una scelta sul mondo che vogliamo lasciare: più pulito, più giusto, più vivibile.