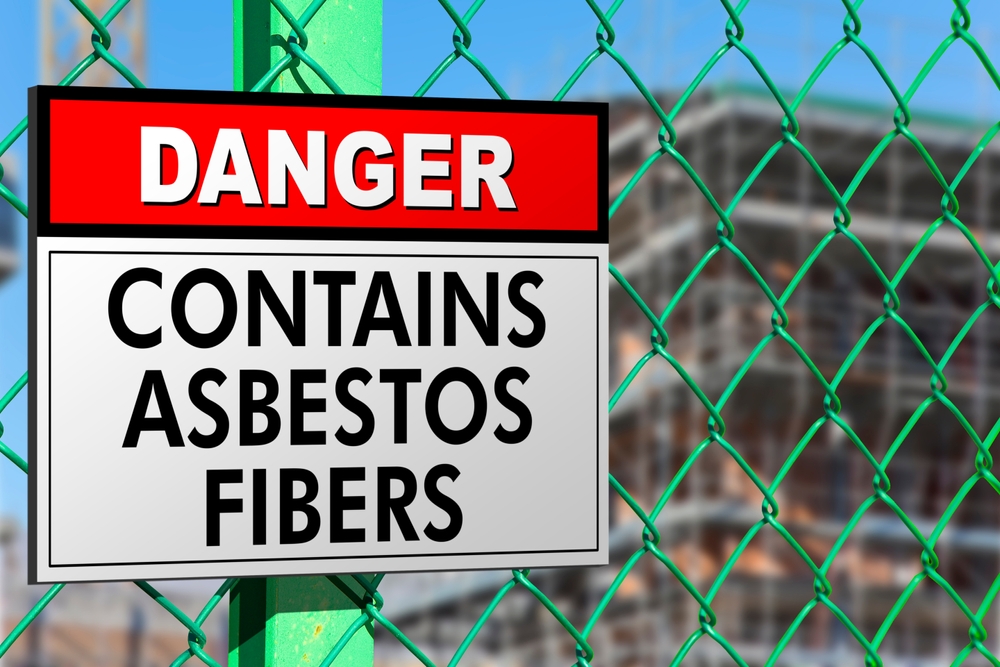Il fenomeno globale dell’accaparramento delle terre minaccia comunità locali e ambienti fragili: ecco come monitoraggio, diritti e pratiche sostenibili possono invertire la tendenza.
Il fenomeno del land grabbing, o accaparramento di terre, rappresenta una delle sfide più critiche per l’ambiente e le società contemporanee. Si tratta di un processo attraverso cui grandi porzioni di suolo, spesso fertili e strategici, vengono acquistate o affittate da attori privati o statali – spesso multinazionali o investitori stranieri – con scarso o nullo coinvolgimento delle comunità locali. Questa pratica ha implicazioni profonde sia dal punto di vista ambientale, perché minaccia la biodiversità e il fragile equilibrio degli ecosistemi, sia da quello sociale, poiché priva le popolazioni indigene e rurali della loro terra, compromettendo la loro sovranità alimentare e i diritti umani fondamentali.
A livello globale, dal cuore dell’Africa subsahariana ai territori del Sud-est asiatico fino all’America Latina, sono centinaia di milioni gli ettari interessati da questo fenomeno. Anche in Italia, sebbene in misura diversa, casi di accaparramento di terre sono oggetto di discussione, soprattutto in relazione a grandi progetti agroindustriali e investimenti speculativi. Per comprendere le dinamiche di questo fenomeno e le sue conseguenze, è fondamentale adottare una lente di giustizia ambientale, che metta al centro la tutela delle comunità e della biodiversità.
Cos’è il land grabbing e come funziona

Ma cos’è il land grabbing nel dettaglio? Il termine indica l’acquisizione massiva di terre da parte di soggetti privati, multinazionali o governi stranieri, spesso senza trasparenza e in condizioni di forte squilibrio di potere. Le terre coinvolte sono generalmente utilizzate per coltivazioni intensive, produzioni destinate all’esportazione, biocarburanti o speculazione fondiaria. Mentre le popolazioni indigene o contadine che vivono su quei terreni vengono spesso espropriate, sfrattate o marginalizzate.
Questo fenomeno è alla base di molti conflitti ambientali, poiché mette in competizione l’interesse economico con il diritto all’accesso alla terra, alla cultura e alla vita delle comunità locali. Le multinazionali e gli investitori agiscono spesso in aree dove le normative sono più deboli o dove la governance è fragile, approfittando di lacune giuridiche e mancanza di controlli. Anche alcuni governi nazionali possono favorire tali operazioni, vedendole come opportunità di investimento o sviluppo economico, a discapito però della popolazione.
Dove si verifica di più e perché
Il fenomeno del land grabbing si concentra prevalentemente in alcune aree geografiche ben definite, in particolare in Africa subsahariana, Sud-est asiatico e America Latina. Secondo i dati di Land Matrix aggiornati a marzo 2022, sono stati registrati oltre 2.600 contratti di acquisizione di terre, riguardanti complessivamente circa 91,7 milioni di ettari, di cui 71 milioni sono investimenti ancora in corso. La forte presenza in Africa subsahariana è dovuta a diversi fattori, tra cui la disponibilità di terreni agricoli relativamente poco sfruttati, la debole regolamentazione fondiaria e la necessità di investimenti esteri per lo sviluppo agricolo. Paesi come Mozambico, Sud Sudan e Liberia risultano tra le aree più colpite, mentre in America Latina si registrano grandi operazioni soprattutto in Perù, Brasile e Argentina.
Come riporta l’ISPI (Istituto per gli studi di politica internazionale), nel Sud-est asiatico, Indonesia e Papua Nuova Guinea sono territori strategici per investitori stranieri, attratti dalle risorse naturali e da condizioni normative favorevoli. L’interesse di investitori provenienti da Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Cina e Giappone rispecchia un mix di motivazioni che vanno dalla sicurezza alimentare al controllo di materie prime, passando per l’espansione di coltivazioni energetiche e industriali.
Tra le cause che hanno accelerato i processi di land grabbing ci sono anche l’aumento della domanda di idrocarburi, il riscaldamento globale, l’aumento di eventi climatici estremi e l’inasprimento di conflitti come quello in Ucraina, tutti elementi che creano un clima di maggiore instabilità e una maggiore richiesta di risorse per far fronte ai bisogni della popolazione mondiale.
Questo quadro evidenzia come il land grabbing non sia solo un fenomeno economico, ma anche geopolitico, che agisce in contesti fragili dove governance e tutela dei diritti locali risultano spesso insufficienti.
Impatti sulle comunità locali e sull’ambiente
Il land grabbing ha conseguenze profonde e spesso drammatiche sulle comunità locali e sull’ambiente. In molte aree coinvolte, l’acquisizione di vaste superfici di terra porta all’espulsione forzata delle popolazioni indigene e rurali, che perdono l’accesso alle proprie terre tradizionali, fondamentali per il loro sostentamento e per la conservazione delle culture locali.
Questa perdita di terre si traduce in una profonda erosione della biodiversità e nella distruzione di habitat naturali preziosi, poiché le aree agricole o forestali vengono convertite in coltivazioni intensive spesso monocolturali. L’intensificazione agricola, che mira alla massimizzazione della produzione, favorisce la diffusione di monocolture e l’uso massiccio di fertilizzanti e pesticidi, causando un impoverimento dei suoli e il degrado delle risorse idriche, spesso contese tra agricoltori locali, investitori e industrie. Questi effetti combinati compromettono non solo l’equilibrio ambientale ma anche la sicurezza alimentare e i diritti delle comunità coinvolte.
Conseguenze dirette del land grabbing:
- Perdita dell’accesso alla terra per le comunità rurali, con espulsioni e conflitti sociali.
- Monocolture intensive e deforestazione, che riducono la biodiversità e alterano gli ecosistemi.
- Impoverimento dei suoli e risorse idriche contese, dovuto all’uso intensivo e insostenibile delle risorse naturali.
Casi studio: tre esempi nel mondo (e uno in Italia)
Il fenomeno del land grabbing si manifesta con dinamiche diverse a seconda dei contesti geografici e socio-economici, ma sempre con effetti significativi su ambiente e comunità locali.
- Etiopia: il land grabbing in Africa ha avuto un impatto rilevante soprattutto in Paesi come l’Etiopia. Qui vaste terre sono state acquisite da investitori stranieri per la creazione di piantagioni intensive, spesso destinate a coltivazioni di esportazione come cotone, caffè o biocarburanti. Come denuncia ActionAid, questi investimenti, sebbene presentati come opportunità di sviluppo, hanno portato a numerosi casi di espulsione forzata delle comunità locali, perdita di accesso alle risorse naturali e degrado ambientale.
- Cambogia: nel Sud-est asiatico, la Cambogia è diventata un terreno privilegiato per investimenti nel turismo e nell’agribusiness. Le acquisizioni di terra da parte di multinazionali e investitori stranieri hanno comportato espropri estesi di terreni agricoli e forestali. Spesso senza un adeguato consenso delle comunità indigene e contadine. Questo ha generato tensioni sociali, conflitti legati ai diritti di proprietà e un forte impatto sull’ambiente, con deforestazione e perdita di biodiversità.
- Piana di Gioia Tauro (Calabria, Italia): anche in Italia, benché in modo diverso, si riscontrano dinamiche riconducibili a forme di accaparramento e speculazione fondiaria. Nella Piana di Gioia Tauro si segnalano casi controversi di investimenti immobiliari e agricoli che hanno alimentato sospetti di speculazione, con impatti sull’uso del territorio, la tutela ambientale e la coesione sociale locale. Tali dinamiche evidenziano come il tema del land grabbing possa avere declinazioni anche in contesti sviluppati, assumendo forme più sottili ma altrettanto problematiche.
Tabella – Confronto tra casi internazionali
| Paese | Tipologia di investimento | Impatto ambientale | Impatto sociale |
| Etiopia | Piantagioni agricole intensive | Degradazione suoli, deforestazione | Espulsione comunità indigene, perdita accesso terra |
| Cambogia | Turismo e agribusiness | Deforestazione, perdita biodiversità | Conflitti per la proprietà, espropri senza consenso |
| Piana di Gioia Tauro (Italia) | Speculazione immobiliare e agricola | Alterazione nell’uso del territorio, rischio idrogeologico | Tensioni sociali, incertezza proprietà, impatto sulla coesione locale |
Come si contrasta il land grabbing: monitoraggio e trasparenza
Contrastare il fenomeno del land grabbing richiede una combinazione di strumenti di monitoraggio, normative efficaci e mobilitazione sociale. In breve ecco alcuni esempi di strumenti e strategie per contrastare il land grabbing:
- Mappature geografiche e database internazionali trasparenti come Land Matrix, che raccolgono e rendono pubblici dati sulle acquisizioni di terra, favorendo la trasparenza e la consapevolezza globale. Sono il modo giusto per monitorare le acquisizioni di terra a livello globale.
- Normative locali e internazionali che tutelano il diritto alla terra e promuovono la responsabilità sociale e ambientale degli investitori. Sono cruciali per limitare le pratiche speculative e garantire i diritti delle comunità rurali e indigene.
- Attivismo e campagne di ONG, quali ActionAid, per denunciare le violazioni e sostenere le comunità colpite.
- Promozione di modelli agricoli sostenibili, come l’agroecologia, che propone un modello agricolo rispettoso della biodiversità e delle risorse naturali, per favorire la resilienza ambientale e sociale.
- Sostenere la giustizia climatica. Questa sottolinea l’importanza di tutelare i territori e le popolazioni vulnerabili dagli effetti diseguali dei cambiamenti climatici, spesso esacerbati dalle grandi acquisizioni di terre. Il modo giusto per affrontare le disuguaglianze legate al controllo delle risorse naturali e agli impatti del cambiamento climatico.
In sintesi
Il land grabbing non rappresenta soltanto una questione globale astratta, ma una minaccia reale e urgente per le comunità che vivono sulla terra e per la ricchezza della biodiversità del nostro pianeta. Solo attraverso una piena trasparenza, il rispetto inalienabile del diritto alla terra e l’adozione di modelli agricoli basati sull’agroecologia potremo invertire questa rotta distruttiva e costruire un futuro più giusto e sostenibile.