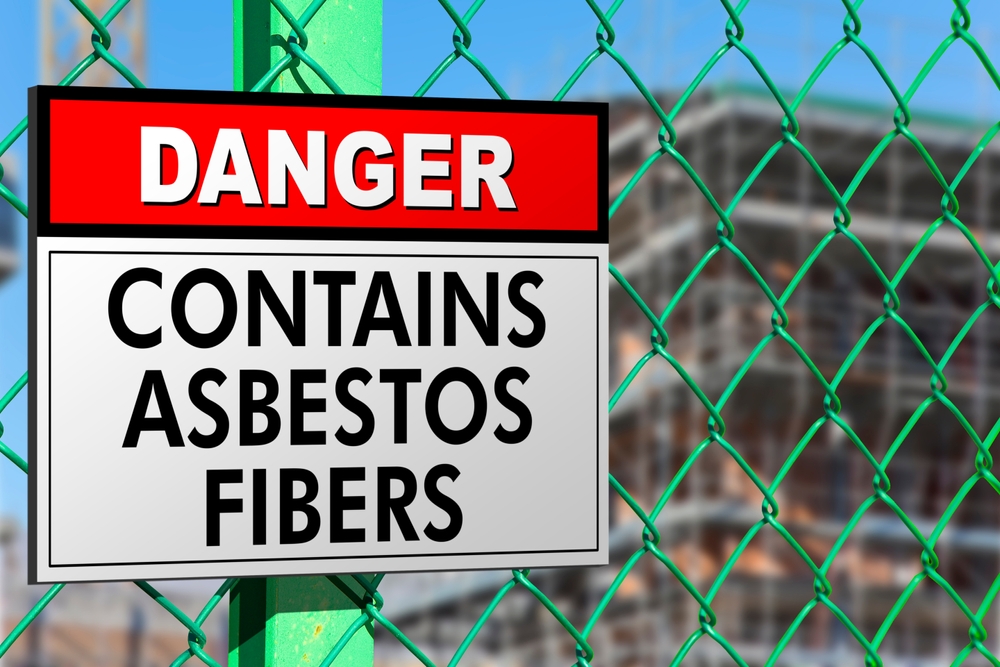Dalla tradizione alla rinascita, i castagneti abbandonati ritrovano valore tra ecologia, economia locale e cultura delle montagne italiane.
Il castagneto non è un bosco selvatico, ma un paesaggio agro-forestale modellato dall’uomo. Per secoli è stato al centro della vita e dell’economia delle comunità montane, dando origine a quella che oggi chiamiamo la “civiltà del castagno“. Oltre a fornire frutti preziosi, tanto da essere chiamato “albero del pane“, i benefici del castagno sono tanti e importanti per il territorio, infatti in primis contribuisce a prevenire l’erosione e il dissesto idrogeologico.
Dopo il dopoguerra, l’abbandono delle montagne e l’arrivo di malattie come il cinipide galligeno hanno determinato un diffuso degrado di questo patrimonio storico. Negli ultimi anni, cooperative di comunità e giovani agricoltori stanno guidando il recupero dei castagneti abbandonati. Come? Trasformando boschi dimenticati in filiere innovative e sviluppando nuove opportunità di turismo sostenibile.
Oggi la rigenerazione dei castagneti rappresenta un modello di sviluppo per le aree interne, capace di coniugare ecologia, economia e cultura, riportando vita e valore in paesaggi che sembravano perduti. Vediamo insieme in che modo.
La “civiltà del castagno”: quando un albero era il centro del mondo

La coltivazione del castagno ha modellato per secoli i versanti montani delle aree interne italiane. Questo ha dato vita a quella che possiamo definire la civiltà del castagno: un sistema agro‑forestale in cui l’albero non era un elemento marginale ma il fulcro della vita quotidiana, del paesaggio e dell’economia delle comunità montane. Le popolazioni locali hanno scelto il castagno perché capace di vivere in condizioni di montagna, fornire frutti nutrienti, legname e materiali, e allo stesso tempo contribuire alla stabilità del terreno.
Con la coltivazione del castagno si costruivano percorsi, si gestivano spazi, si essiccavano le castagne; insomma, si intrecciava una relazione stretta tra uomo, albero e territorio. Questo modello è oggi riscoperto non solo come memoria storica, ma come possibilità di rigenerazione per le aree interne abbandonate.
L'”albero del pane”: il ruolo del castagno nell’alimentazione montana
In molte zone montane, la farina di castagne rappresentò per lungo tempo la base alimentare delle famiglie rurali: quando i cereali erano difficili da coltivare o reperire, la castagna assumeva la funzione del pane e divenne simbolo stesso di sostentamento. Il frutto del castagno veniva essiccato, macinato e trasformato, diventando un alimento essenziale nei mesi più rigidi. Questo ruolo alimentare ha consolidato la centralità dell’albero nelle economie montane, testimoniando quanto la civiltà del castagno fosse legata alla quotidianità e alla sopravvivenza.
Un ecosistema costruito dall’uomo: il castagneto da frutto
Il paesaggio del castagneto da frutto è molto diverso da un bosco spontaneo di castagni selvatici: non si tratta di alberi che crescono indisturbati, ma di un ecosistema antropizzato, progettato e curato. In un castagneto coltivato troviamo spesso muretti a secco che delimitano terrazze, percorsi di raccolta ben definiti, “caselle” e strutture per l’essiccazione delle castagne, e una gestione costante del soprassuolo.
Come specifica CREA (Centro di ricerca Foreste e Legno), nei castagneti da frutto la gestione attiva tramite potature, diradamenti ecc., è fondamentale per aumentare la produttività e ridurre i costi. Rispetto al bosco selvatico, dove il castagno è solo uno tra gli alberi e la selezione naturale regna, nel castagneto coltivato l’uomo ha imposto struttura e ordine. Ciò consente non solo la produzione del frutto ma anche la stabilità dei versanti, la fruibilità del territorio e la continuità di utilizzo. In questo modo la coltivazione del castagno non riguarda solo economia e alimentazione, ma anche paesaggio, stabilizzazione e manutenzione del territorio.
Le minacce di oggi: dall’abbandono al cinipide
L’arretramento della gestione attiva dei castagneti, unito alla crescente vulnerabilità dei versanti montani, mette in luce rischi ambientali crescenti, tra cui il dissesto idrogeologico degli Appennini. In molte parti della dorsale appenninica, la perdita della manutenzione – dalle cure ai castagneti alla regimazione delle acque superficiali – ha indebolito i versanti. Allo stesso tempo, un nuovo agente di disturbo, il cinipide del castagno, si è affacciato come minaccia alla produzione e alla vitalità dei castagneti.
L’abbandono delle montagne e le sue conseguenze
Con lo spopolamento e la fine di molte attività tradizionali, i castagneti, e più in generale il paesaggio montano, sono entrati in una fase di rilassamento gestionale: i castagneti non più curati tendono a trasformarsi in boschi più disordinati, meno controllati e maggiormente esposti al rischio incendi, frane e grandi dissesti.
Come si legge su AgenFood, in particolare la mancanza di interventi di manutenzione sui terrazzamenti, i muretti a secco, la rete di drenaggio delle acque superficiali, e la riduzione della potatura e raccolta regolare, rende i versanti più fragili: la trasformazione da paesaggio controllato a “bosco ingovernato” amplifica il rischio che l’abbandono favorisca fenomeni quali smottamenti e dissesti idrogeologici.
Il cinipide galligeno: la vespa che ha messo in ginocchio la produzione
La comparsa del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus), noto anche come “cinipide galligeno”, ha rappresentato un grave colpo per la castanicoltura italiana: segnalato per la prima volta in Italia nel 2002, l’insetto ha rapidamente colonizzato vaste aree castanicole. Come spiega anche l’INSPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), attraverso la formazione di galle nei germogli e nelle gemme apicali, limita fortemente la fruttificazione e la vitalità dell’albero.
Le strategie di lotta biologica, basate sull’introduzione dell’antagonista Torymus sinensis, hanno evidenziato una parziale ripresa: le analisi del programma di controllo mostrano che il parassitoide può contenere l’infestazione ma senza garantire l’eliminazione totale del parassita. Nei suoi momenti peggiori, la crisi aveva fatto registrare un crollo della produzione nazionale di castagne di oltre l’80 %, rendendo questo fenomeno non solo una minaccia fitosanitaria, ma anche economica e territoriale.
La rinascita: 3 modelli di rigenerazione del castagneto
Il recupero dei castagneti abbandonati sta dando nuova vita alle aree interne dell’Appennino, grazie a progetti che combinano ecologia, cultura e sviluppo economico. In questo contesto, la filiera della castagna si reinventa, valorizzando non solo il frutto, ma l’intero paesaggio agro‑forestale e le comunità che lo abitano.
1. Le cooperative di comunità
In diverse zone dell’Appennino, piccoli comuni e gruppi di cittadini si sono uniti per gestire collettivamente i castagneti. Queste cooperative di comunità promuovono la produzione locale, creano posti di lavoro e, in alcuni casi, sviluppano un marchio territoriale che valorizza la qualità e la tradizione delle castagne. L’azione collettiva permette di affrontare meglio le sfide della manutenzione e della commercializzazione, rafforzando la resilienza dei territori montani. Un esempio è la Cooperativa di Comunità ViviComano in Lunigiana, che ha coinvolto giovani e residenti impegnati a ripulire castagneti da frutto, ripristinare sentieri e essiccatoi, e rilanciare la produzione di farina di castagne locale.
2. L’innovazione di prodotto
La rigenerazione del castagneto non si limita alla farina tradizionale: oggi la filiera della castagna si espande con prodotti innovativi che uniscono tradizione e creatività. Ad esempio, l’azienda agricola di Marco Bozzolo (Valle Tanaro, Piemonte) ha introdotto creme spalmabili, linee di pasta secca, cosmetici a base di foglie di castagno e pellet di alta qualità dal legno di potatura. Inoltre, si trova documentazione della produzione italiana di birre alla castagna: la birra alle castagne diventa uno strumento per legare l’ingrediente al territorio, favorire l’appeal del prodotto e dare slancio alla filiera.
3. Il turismo esperienziale
Il paesaggio del castagneto e la produzione legata alla castagna stanno diventando anche motore di turismo rurale, offrendo esperienze dirette e coinvolgenti. In certe zone dell’Appennino, si propongono percorsi di trekking tra i castagneti, workshop di raccolta e lavorazione, soggiorni in “caselle” o essiccatoi restaurati, e laboratori di cucina con farina di castagne. Un esempio di valorizzazione territoriale è descritto da Slow Food Italia che racconta come giovani produttori abbiano riaperto un essiccatoio storico e organizzino corsi di cucina e trasformazione a partire dalla castagna.
Attraverso il turismo rurale, il castagneto non è solo un sistema produttivo, ma diventa anche attrazione culturale e ambientale, rafforzando il legame tra comunità, paesaggio e visitatori.
I benefici di un castagneto in salute
Un castagneto gestito con cura rappresenta molto più di una semplice coltivazione: è un sistema agro‑forestale che unisce benefici ecologici, economici e culturali, con effetti diretti sul territorio, sulla comunità e sul paesaggio, come stiamo per vedere.
1. Prevenzione del dissesto idrogeologico
Il castagno possiede un apparato radicale esteso che consolida il terreno, riducendo il rischio di erosione, frane e smottamenti. La lettiera di foglie e rami caduti contribuisce a trattenere l’umidità e a proteggere il suolo dall’impatto delle piogge, specialmente sui ripidi versanti appenninici.
Impatto: castagneti ben gestiti funzionano come vere barriere naturali contro il dissesto idrogeologico, mitigando i rischi per abitazioni, strade e infrastrutture locali. La manutenzione dei terrazzamenti, dei muretti a secco e dei percorsi pedonali aumenta ulteriormente la stabilità dei versanti.
2. Aumento della biodiversità
Un castagneto maturo e ben curato ospita una grande varietà di specie: funghi commestibili, insetti impollinatori, uccelli come il picchio e piccoli mammiferi. Le zone di sottobosco e i vecchi alberi creano corridoi ecologici che collegano habitat diversi e favoriscono la dispersione naturale della fauna.
Impatto: l’incremento della biodiversità rende l’ecosistema più resiliente agli stress ambientali, come siccità o infestazioni di parassiti, e contribuisce alla conservazione di specie locali a rischio. I castagneti diventano così laboratori naturali di osservazione e conservazione.
3. Stoccaggio di carbonio
I castagni sono alberi longevi che accumulano carbonio nel legno e nel suolo per decenni. La gestione sostenibile dei castagneti aumenta la capacità di sequestro del carbonio, contribuendo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.
Impatto: oltre a ridurre la concentrazione di gas serra nell’atmosfera, la pratica del recupero dei castagneti abbandonati trasforma il paesaggio in uno strumento concreto di lotta al riscaldamento globale. La combinazione di alberi maturi e suolo fertile crea un vero e proprio “serbatoio di carbonio naturale”.
4. Creazione di filiera locale
Il castagneto supporta un’intera filiera produttiva, dalla raccolta delle castagne alla trasformazione in farine, marmellate, marroni e altri prodotti tipici. La valorizzazione locale permette di promuovere marchi territoriali e prodotti a denominazione di origine.
Impatto: questa filiera crea occupazione, soprattutto per i giovani agricoltori, favorisce l’economia locale e contribuisce a contrastare lo spopolamento dei borghi appenninici. La gestione dei castagneti diventa quindi un motore di sviluppo rurale sostenibile.
5. Manutenzione del paesaggio
La cura dei castagneti preserva un paesaggio culturale unico, fatto di alberi secolari, muretti a secco, essiccatoi e percorsi storici. Come spiega il Centro di Studio e Documentazione sul Castagno, il castagneto è un elemento identitario che racconta la storia delle comunità montane e delle tecniche tradizionali.
Impatto: la gestione dei castagneti aumenta l’attrattività turistica, promuove il turismo rurale e permette di tramandare conoscenze e tradizioni legate al territorio. Il paesaggio diventa quindi una risorsa viva, economica e culturale insieme.
Il ruolo dei presìdi slow food
Per salvaguardare il patrimonio dei castagneti e delle varietà tradizionali, Slow Food ha istituito diversi Presìdi dedicati a castagne e marroni di alta qualità. Tra questi, il Marrone di Castel del Rio in Emilia-Romagna e la Castagna di Montella in Campania rappresentano due esempi di varietà storiche che rischiavano di scomparire.
Questi progetti supportano i piccoli produttori locali, aiutandoli a farsi conoscere e a ottenere un giusto prezzo per il loro lavoro, incentivando la coltivazione sostenibile di varietà autoctone. Allo stesso tempo, contribuiscono a preservare i paesaggi tradizionali dei castagneti, che raccontano la storia e le pratiche agricole delle comunità montane. L’iniziativa rientra nel programma più ampio dei Presìdi Slow Food, pensato per tutelare la biodiversità agricola e valorizzare i prodotti tipici italiani.
Lo sapevi? Nei castagneti tradizionali, alcuni alberi secolari venivano chiamati “madri” perché fornivano i frutti migliori per la riproduzione. Ogni comunità montana custodiva e tramandava la conoscenza di queste piante “speciali”, considerate vere e proprie radici genealogiche del bosco, da cui dipendeva la qualità di tutta la produzione.
In sintesi
Il ritorno del castagneto rappresenta molto più di un recupero agricolo: è la rinascita di un paesaggio identitario che unisce memoria, biodiversità e innovazione. Attraverso la cura dei boschi, la filiera della castagna e il coinvolgimento delle comunità locali, le montagne italiane ritrovano equilibrio e nuove opportunità. Un esempio concreto di come la natura, quando viene ascoltata e gestita con rispetto, possa diventare motore di rigenerazione ecologica, economica e culturale.
Video: Scrigni di biodiversità: Andrea Maroè introduce la gestione e recupero del castagno storico
Il video racconta il recupero dei paesaggi terrazzati delle Valli del Natisone, un progetto che mira a valorizzare un territorio ricco di biodiversità attraverso la cura dei castagneti e la manutenzione dei terrazzamenti tradizionali. Finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con fondi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il progetto coinvolge comunità locali e associazioni per riportare in vita un paesaggio rurale storico. Nel video, l’arbonauta Andrea Maroè sottolinea l’importanza della cura delle piante di castagno come azione chiave per mantenere in salute l’ecosistema e prevenire il degrado del territorio.