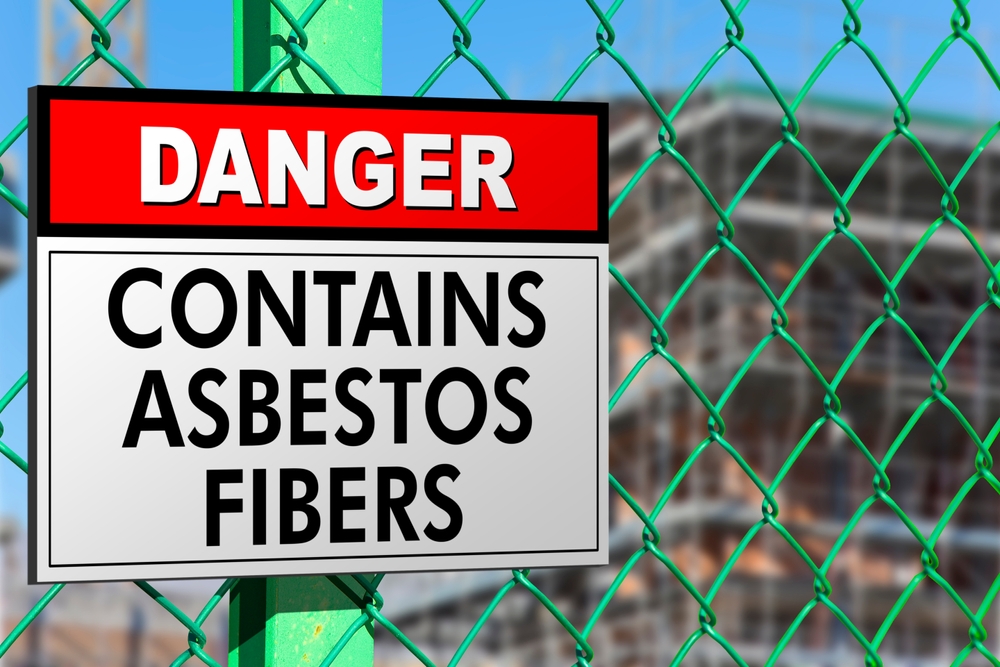Dalla Pianura Padana all’Europa, il progetto SUPERB sperimenta strategie innovative di riforestazione urbana e periurbana, unendo scienza, governance e partecipazione per costruire
Il ripristino ecologico non è più una scelta facoltativa, ma una priorità per affrontare la crisi climatica e la perdita di biodiversità. Le foreste, in questo scenario, svolgono un ruolo cruciale: assorbono carbonio, ospitano la maggior parte della biodiversità terrestre europea, regolano il ciclo dell’acqua, mitigano gli effetti delle ondate di calore e offrono spazi di benessere per le comunità.
Negli ultimi anni è cambiato il modo di concepire il restauro ecologico. Se in passato l’obiettivo era riportare gli ecosistemi a uno stato “originario”, oggi la sfida è renderli capaci di affrontare i cambiamenti futuri. È il concetto di prestoration: progettare interventi che, oltre a recuperare aree degradate, le rendano resilienti a climi più caldi, eventi estremi più frequenti e nuove esigenze sociali. Questo significa scegliere specie vegetali resistenti alla siccità, ripensare la gestione forestale e, soprattutto, coinvolgere cittadini e comunità locali.
Il progetto SUPERB per il ripristino forestale
Con queste premesse nasce SUPERB (Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services), il più ampio progetto scientifico europeo dedicato al ripristino forestale. Finanziato dal programma Horizon 2020 con un budget di circa 20 milioni di euro, il progetto coinvolge 36 università, centri di ricerca, istituzioni e associazioni.
La sua forza sta nelle 12 aree dimostrative distribuite in tutti i principali biomi europei: dalle foreste boreali della Svezia a quelle mediterranee della Spagna e del Portogallo, passando per le foreste temperate di Germania e Austria, fino a quelle planiziali italiane. Ogni demo sperimenta soluzioni calibrate sul contesto: conversione di monocolture in boschi misti, arricchimenti genetici, interventi idrologici per riconnettere fiumi e foreste alluvionali, riduzione del combustibile per prevenire incendi, fino a tecniche innovative come l’uso di idrogel per trattenere acqua e favorire la sopravvivenza delle giovani piantine.
I primi risultati sono concreti: in Francia la conversione di piantagioni di conifere ha aumentato la diversità specifica del 30%; in Romania la riconnessione idrologica ha ripristinato oltre 20 km di canali laterali; in Portogallo la diversificazione colturale ha ridotto del 60% la propagazione potenziale degli incendi.
Si inizia da Milano
In Italia il progetto si concentra nella Città Metropolitana di Milano, una delle aree più urbanizzate e frammentate d’Europa, con meno del 5% di copertura forestale. Qui SUPERB ha realizzato quattro impianti pilota di forestazione urbana e periurbana, su 11 ettari ad uso ex agricolo nei comuni di Legnano, Vittuone, Inveruno e Villa Cortese.
Gli obiettivi sono molteplici: ricostruire frammenti di foresta planiziale, migliorare la qualità dell’aria e ridurre le isole di calore, aumentare la biodiversità e creare nuovi spazi verdi accessibili. Ma anche sperimentare soluzioni innovative:
- densità diverse di piantagione (da 1.500 a 2.500 piante/ha) per valutare crescita, microclima e sopravvivenza;
- provenienze diverse dei semi (nord, centro e sud Italia) per identificare genotipi più resilienti alla siccità;
- uso di idrogel per migliorare la ritenzione idrica.
Dopo 18 mesi i risultati sono incoraggianti: oltre il 75% delle piantine è sopravvissuto, con performance migliori nei moduli che hanno utilizzato idrogel. Le densità intermedie si sono dimostrate le più efficaci, bilanciando crescita e competizione idrica.
Il coinvolgimento della cittadinanza
Il successo della demo italiana non dipende solo dagli aspetti tecnici, ma anche dalla partecipazione. Sono stati organizzati tre workshop di coprogettazione con cittadini, scuole e amministrazioni. Le comunità hanno contribuito alla scelta delle specie, alla definizione dei percorsi e alla pianificazione della manutenzione. Oltre 600 studenti e 40 insegnanti hanno preso parte alle giornate di piantagione e ai laboratori sul campo. Un’esperienza che ha rafforzato la consapevolezza ambientale dei più giovani: più dell’80% ha dichiarato di aver aumentato le proprie conoscenze su alberi e biodiversità urbana.
Questo approccio inclusivo ha trasformato i nuovi boschi in spazi riconosciuti e condivisi, riducendo conflitti e aumentando il senso di appartenenza. Non solo interventi ambientali, ma infrastrutture sociali capaci di generare coesione e benessere.
Le esperienze maturate nei quattro siti pilota sono solo l’inizio. L’obiettivo è scalare le soluzioni testate e raggiungere 200-300 ettari di nuove foreste urbane e periurbane entro il 2030, contribuendo anche al programma ForestaMi, che punta a mettere a dimora 3 milioni di alberi nell’area metropolitana di Milano.
Le proiezioni basate sui modelli mostrano che questi impianti, tra 20 e 30 anni, potranno accumulare oltre 50 tonnellate di carbonio per ettaro, raggiungendo valori comparabili alle foreste planiziali mature. In uno scenario di clima sempre più caldo e siccitoso, questi boschi urbani rappresenteranno un laboratorio di adattamento e un polmone verde per milioni di cittadini.
I primi insegnamenti del progetto SUPERB
Dalle esperienze di SUPERB emergono insegnamenti chiari:
- il ripristino è un processo lungo che richiede manutenzione e monitoraggio costante;
- la diversità ecologica e genetica è la chiave della resilienza;
- senza partecipazione e coprogettazione, la forestazione urbana rischia di fallire;
- innovazioni tecniche come idrogel e selezione delle provenienze aprono nuove prospettive;
- la replicabilità passa da infrastrutture di conoscenza condivisa
SUPERB dimostra che il ripristino ecologico è anzitutto una trasformazione culturale e politica: un nuovo modo di abitare i territori, in cui scienza, governance e società si incontrano per costruire paesaggi più resilienti e inclusivi.