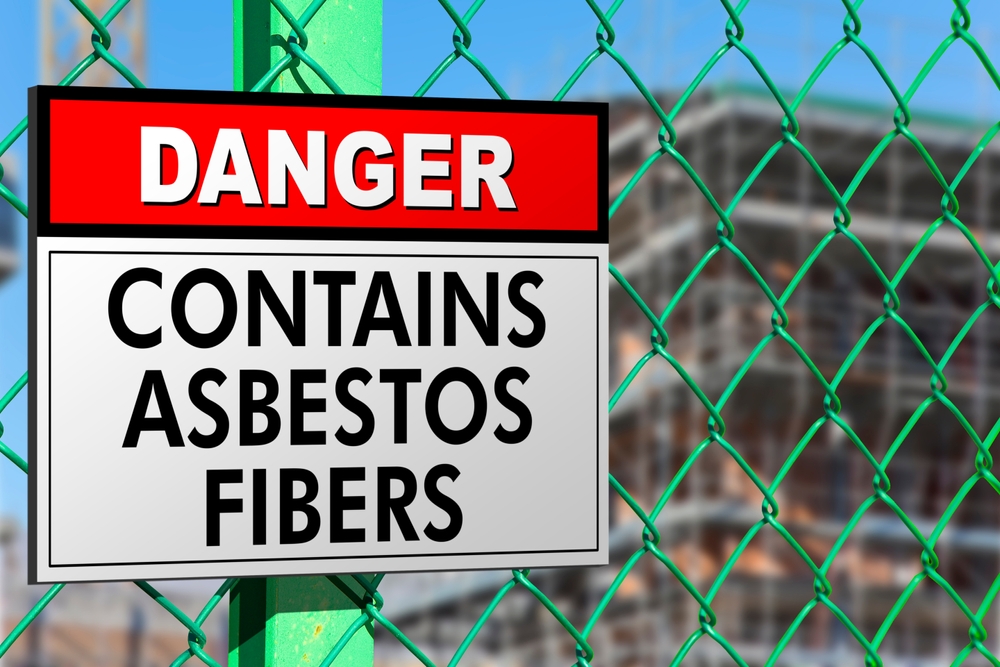Serve ad individuare, lungo il corso di un fiume, il punto più adatto per ospitare una cassa di espansione, che riduce il rischio di esondazioni. È il lavoro per la tesi di laurea del 26enne sanmarinese Luca Censoni, che per questo ha meritato il premio Duccio Forlani.
Un flusso di bit che contribuisce ad irregimentare il flusso d’acqua di un fiume in piena riducendo il rischio di esondazioni e alluvioni. Potere degli algoritmi. Potere di Luca Censoni, il 26enne sanmarinese che l’algoritmo in grado di abbattere i rischi idrogeologici lo ha creato come propria tesi di laurea e che per questo è stato insignito del premio di laurea Duccio Forlani, organizzato dall’Università degli Studi della Repubblica di San Marino in collaborazione con lo studio di ingegneria e geologia Sgai di Morciano di Romagna.
“Si tratta di un lavoro sulla mitigazione del rischio idrogeologico”, ha sottolineato il docente universitario Filippo Forlani, amministratore delegato dello studio Sgai e figlio del geologo al quale è dedicato il concorso.
“In questo ambito è stato sviluppato un algoritmo che, sulla base di una serie di caratteristiche e di un modello digitale del terreno, individua il punto più adatto per ospitare una cassa di espansione in linea, cioè un bacino nel quale l’acqua, in caso di forti piogge, viene parzialmente trattenuta e rilasciata lentamente per non comportare o per mitigare disagi più a valle”. In particolare il lavoro di Censoni ha riguardato alcune aree ed edifici di una frazione di Santarcangelo di Romagna interessati in passato dall’esondazione del Rio Gessi.
Dal terreno ai bit all’ingegneria idraulica
Partiamo dal problema. C’è un corso d’acqua, il Rio Gessi, che in rari casi di piena più raggiungere una portata di poco superiore ai 30 meri cubi al secondo (m3/s). Difficile immaginare cosa questo voglia dire. Ma è facile capire le conseguenze di questa portata occasionale se, come pazientemente fa con me al telefono Censoni, si spiega che nei pressi della frazione Lo Stradone di Santarcangelo di Romagna tutta quest’acqua finisce per arrivare là dove la portate è invece di circa 8m3/s.
Si tratta di fatto di strettoie legate all’artificializzazione e cementificazione del corso d’acqua. Quello che accade, nei momenti di piena, è come un’autostrada a 3 corsie che improvvisamente si riduce ad una sola in una giornata di traffico da bollino rosso. Come pretendere di vuotare una bottiglia rovesciandola in una cannuccia. Tutti i metri cubi di porta in eccesso rispetto alla strettoia se ne andranno nelle strade, rischiando di trascinare via persone e cose.
La soluzione vincitrice del premio Duccio Forlani
La soluzione immaginata per ridurre questo rischio si chiama vasca di laminazione o cassa di espansione: un serbatoio artificiale (a cielo aperto o interrata) che accumula temporaneamente l’acqua in eccesso e permette così di mitigarne il flusso. Nello specifico caso romagnolo la vasca, a monte del centro abitato e della strettoia, viene ottenuta frapponendo al cammino delle acque, lungo il fiume, uno sbarramento in terra.
“Per accumulare l’acqua a monte dello sbarramento”, mi spiega Censoni: “In modo che dei 30 metri cubi d’acqua al secondo di portata solo una parte fluisce attraverso l’opera d’imbocco, l’altra si accumula” nella zona predisposta appunto per accogliere l’acqua. Lo sbarramento infatti, ovviamente, non ostruisce completamente l’alveo: un condotto (detto appunto opera di presa o di imbocco) consente il passaggio di una certo numero di metri cubi al secondo, non di più. Giusto quelli che arrivando poi più a valle, nella strettoia (8m3/s), non daranno problemi.
Il lavoro dell’algoritmo
Fin qui solo banale ingegneria idraulica. E l’algoritmo? Intanto diamogli un nome: si chiama SELT, che sta per “Search and Evaluate Lamination Tank”. SELT permette di semplificare la ricerca della posizione della vasca, di valutare l’altezza dello sbarramento necessario e l’area allagata dall’accumulo dell’acqua in caso di piena. In che modo? Lo fa partendo dal Digital Terrain Model (DTM): una rappresentazione digitale del suolo, diviso in celle tutte della stessa superficie (la dimensione può variare in base alle scelte dell’utilizzatore), ciascuna caratterizzata dalla propria elevazione rispetto al livello del mare.
L’algoritmo prende in considerazione tante celle del modello con le relative quote altimetriche e simulando la pioggia definisce le linee di deflusso: cioè il percorso dell’acqua piovana, dalle celle a quota più alta a quella a quota via via più bassa, fino al fiume. Si costruisce così il reticolo di deflusso che connette le celle tra di loro e che di fatto rappresenta il flusso dell’acqua piovana verso il fiume.
E arriviamo alla vasca di laminazione. Lungo l’asse del fiume, ad una certa distanza l’uno dall’altro, l’algoritmo sceglie dei punti dove ipotizza lo sbarramento. E per ogni sbarramento ipotizzato calcola quanto dovrà essere alto per accumulare, a monte, una quantità d’acqua definita (l’ipotesi di Censoni è 30.000 metri cubi, sufficienti a mitigare una piena da 30m3/s) e quanto spazio occuperà questo volume d’acqua. E questo calcolo lo fa per un gran numero di punti lungo l’asta fluviale. “Ma l’algoritmo – precisa – non dà la soluzione: offre ipotesi che sta a noi valutare e verificare. Ci dà un’indicazione, poi serve un sopralluogo per capire se ha senso mettere lì lo sbarramento o in un altro punto. Andrà insomma fatta una valutazione critica che, partendo dal calcolo, vada oltre il calcolo”.
I possibili impieghi
La tesi di Censoni, laureato magistrale in Ingegneria civile, “è importante perché contribuisce a un progetto promosso dal Consorzio di Bonifica della Romagna che, una volta realizzato, comporterà vantaggi sul fronte della sicurezza e a beneficio delle comunità della zona”, evidenzia il professor Forlani. E poi l’impiego di SELT non è limitato a questo singolo caso specifico ma può essere applicato ad altri corsi d’acqua: “Ne ho testato il funzionamento anche in altre zone: l’algoritmo – chiarisce il giovane ingegnere – funziona anche con altri DTM”.