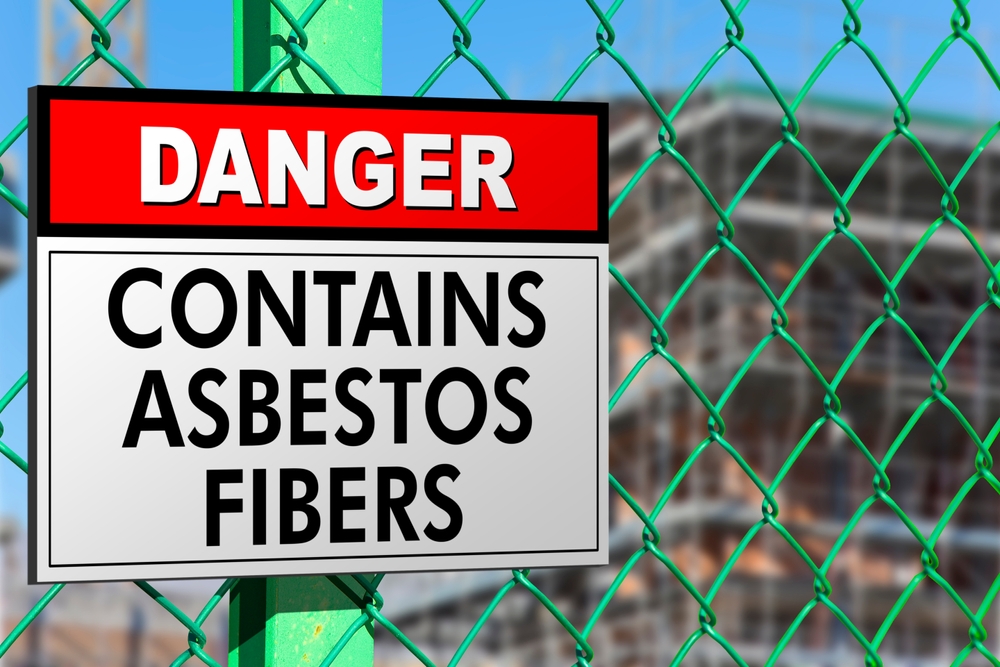Il turismo rigenerativo trasforma i viaggiatori in co-creatori di valore, offrendo esperienze che lasciano un impatto positivo e duraturo su ambiente, comunità e territorio, e promuovendo la rigenerazione dei luoghi visitati.
Negli ultimi anni i concetti di viaggi sostenibili e turismo consapevole hanno guadagnato grande visibilità: parliamo di ridurre l’impronta ecologica, minimizzare gli sprechi, compensare le emissioni di CO₂. Tuttavia, queste pratiche, pur fondamentali, spesso si limitano a contenere il danno. Il turismo rigenerativo va oltre: l’obiettivo non è tanto avere un impatto “zero”, quanto generare un impatto positivo misurabile. Ciò significa che il luogo che visitiamo non solo non soffre a causa della nostra presenza, ma migliora grazie ad essa, sotto diversi aspetti.
Questo approccio si fonda su tre pilastri principali: migliorare la salute degli ecosistemi locali, rafforzare la resilienza della comunità ospitante e favorire la crescita personale del viaggiatore. In contrasto con il turismo tradizionale, dove il visitatore tende ad essere un consumatore di servizi (alloggi, trasporti, escursioni), il turismo rigenerativo trasforma il turista in un co-creatore attivo del valore per il territorio. Questo può avvenire tramite attività concrete: per esempio partecipare al ripristino di muretti a secco, al monitoraggio della biodiversità locale o al restauro di terreni degradati.
Per riconoscere un’esperienza davvero rigenerativa, non basta guardare le belle parole: occorre analizzare dove vanno i soldi spesi e quali connessioni reali si creano con la comunità locale. In cosa vengono investite le tariffe? Chi beneficia realmente? Quanto viene coinvolta la popolazione? Senza queste verifiche, il rischio è che “turismo rigenerativo” diventi un’etichetta vuota. Vediamo quindi in cosa consiste il turismo rigenerativo, quali sono le potenzialità e i limiti e cosa possiamo fare noi concretamente.
Dal “Non lasciare tracce” al “Lascia una traccia positiva”: la rivoluzione del viaggio

Questa frase può sembrare una piccola variazione di linguaggio, ma indica una svolta profonda. “Non lasciare tracce” è stato il mantra del turismo sostenibile: non danneggiare, non inquinare, non disturbare. “Lascia una traccia positiva” implica invece che il visitatore abbia un ruolo attivo nel miglioramento del luogo: che la sua presenza produca benefici, non solo che eviti di causare danni. È una rivoluzione nel modo di concepire il viaggio, che porta le persone a trasformare le proprie vacanze in esperienze green capaci di rigenerare ecosistemi, comunità e persino sé stessi.
I limiti del turismo sostenibile: perché minimizzare il danno non basta più
Il turismo sostenibile è stato ed è un progresso importante: ha promosso pratiche come la riduzione dell’impronta di carbonio, l’uso di energie rinnovabili negli alloggi, la minimizzazione degli sprechi, l’evitare di disturbare fauna e flora.
Tuttavia, vediamo ogni aspetto nel dettaglio e i suoi limiti:
- Riduzione dell’impronta: ridurre le emissioni è utile, ma resta solo mitigativo. Anche al minimo, alcune attività turistiche (trasporti, impatti infrastrutturali) producono effetti negativi.
- Compensazione CO₂: dare soldi per piantare alberi o comprare crediti carbonio è diffuso, ma la qualità di queste compensazioni spesso è incerta, e potrebbero non avere un’efficacia significativa o duratura.
- Non disturbare: il principio è buono, ma passivo. Evitare di infastidire non crea benefici: lascia semplicemente che il sistema resti com’era.
Questi limiti rendono chiaro che minimizzare il danno non è più sufficiente: oggi molte destinazioni sono degradate, ecosistemi impoveriti, comunità locali fragili. Serve un approccio che ripari, che migliori, non solo che preservi.
Definire il turismo rigenerativo: un approccio olistico che crea valore
Il turismo rigenerativo si delinea come un paradigma olistico, che considera il sistema nel suo insieme: ecologico, sociale, culturale ed economico. Non è un semplice insieme di pratiche “verdi”: è un modo di pensare che mette al centro la capacità del luogo, l’ecosistema + la comunità, di rinnovarsi, prosperare, diventare più forte grazie all’interazione con i visitatori.
Ecco alcune caratteristiche distintive, spiegate anche nel Journal of tourism futures di Emerald Insight:
- Creazione di rete di impatto positivo (“net positive benefit”) su ambiente e comunità, non solo neutralizzazione del danno.
- Basarsi su conoscenze locali, saperi tradizionali, condivisione del potere decisionale con le comunità ospitanti.
- Approccio sistemico: il turismo non viene considerato come settore separato, ma integrato con agricoltura, biodiversità, cultura, salute degli ecosistemi.
- Apprendimento continuo: monitoraggio, riflessione, adattamento. Non è un “programma una tantum”, ma un processo evolutivo nel tempo.
I 3 pilastri interconnessi: ambiente, comunità e individuo
Un’efficace esperienza rigenerativa produce benefici simultanei per tre ambiti:
- Ambiente / ecosistemi locali: migliorare la salute ecologica può significare restaurare habitat naturali, aumentare la biodiversità, rigenerare suoli, rigenerare foreste o terreni degradati. Per esempio, un progetto rigenerativo può includere il ripristino di una vegetazione autoctona, il miglioramento della qualità dell’acqua o del suolo, la rimozione di specie invasive.
- Comunità locale: rafforzare la resilienza significa migliorare le condizioni socio-economiche della popolazione: generare lavoro locale significativo, mantenere culture e tradizioni, dare voce e responsabilità ai residenti nelle decisioni che riguardano il territorio, distribuire equamente i benefici del turismo.
- Favorire la crescita personale dell’individuo – viaggiatore: l’esperienza diventa trasformativa per chi viaggia. Si sviluppano consapevolezza ambientale, empatia, comprensione culturale, capacità di collaborazione. Il viaggiatore esce dal viaggio non solo con ricordi, ma spesso con un nuovo sguardo sul mondo, nuove competenze, possibilità di contribuire concretamente.
Un esempio concreto rende chiaro questo intreccio: aiutare un contadino locale a recuperare un terrazzamento abbandonato significa stabilizzare il suolo e favorire la biodiversità (ambiente), restituire al contadino un terreno produttivo e un’opportunità di reddito (comunità), e offrire al viaggiatore un’esperienza trasformativa fatta di apprendimento e connessione autentica con il territorio (individuo).
5 Esperienze concrete di turismo rigenerativo in Italia
Entriamo ora nel dettaglio di alcune esperienze in cui si osserva come il turismo può fare da leva non solo economica, ma anche culturale, sociale e ambientale per le comunità ospitanti.
L’albergo diffuso come presidio sociale: il caso di Ex-Fadda a San Vito dei Normanni
L’ExFadda a San Vito dei Normanni in provincia di Brindisi, in Puglia, è un laboratorio urbano promosso dal Comune, dalla Regione Puglia e da varie associazioni locali nell’ambito del programma per le politiche giovanili “Bollenti Spiriti”. È nato dalla trasformazione di un vecchio stabilimento enologico abbandonato in un centro culturale multifunzionale, con spazi per laboratori, teatro, musica, centro ludico, bar, giardino. L’ExFadda non è semplicemente un luogo dove dormire o consumare servizi: è uno spazio di aggregazione, innovazione sociale, inclusione, creatività, partecipazione attiva della comunità ospitante.
Altre iniziative all’interno del progetto includono XFood, un ristorante sociale che impiega persone con svantaggi (tra cui persone disabili) e che punta anche ad agricoltura biologica, orto e relazioni con il territorio. Questo rende L’ExFadda non solo un’attrazione culturale, ma un presidio sociale concreto.
Agricoltori custodi di biodiversità: recuperare terrazzamenti in Liguria
In Liguria, i terrazzamenti e i muretti a secco sono un patrimonio agricolo, paesaggistico e ambientale fondamentale, sia per contrastare il dissesto idrogeologico, sia per preservare biodiversità e tradizioni locali. Ci sono bandi (Programma di Sviluppo Rurale, PSR) regionali specifici per il ripristino di muretti a secco: ad esempio la sottomisura 4.4 per il “ripristino di tratti di muro a secco tradizionale per i terreni agricoli”, che hanno richiesto anche che i terreni e i muretti siano identificabili, gestiti, ecc.
Un esempio pratico: l’Azienda Agricola Carlo Siffredi (Lucinasco, Imperia) partecipa al progetto “Oliveti Aperti”: l’azienda ha recuperato oltre 15.000 m² di muretti a secco e 20 ettari di terreni abbandonati; offre visite ad oliveti, frantoi, e attività didattiche collegate ai muretti a secco, dove i visitatori possono apprendere il loro valore ecologico, paesaggistico e pratico. Ciò crea un collegamento diretto con la comunità locale, valorizzando saperi tradizionali e producendo un beneficio ambientale (meglio stabilità del suolo), economico (valorizzazione dei prodotti locali) e formativo per il visitatore.
“Citizen Science” in vacanza: monitorare la fauna nel Parco Nazionale d’Abruzzo
Nel Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise alcuni tour operator propongono trekking guidati da biologi o naturalisti per osservare orso marsicano e lupo appenninico. I partecipanti imparano a riconoscere tracce, segni di presenza e a compilare semplici schede di campo, contribuendo, in alcuni casi, alla raccolta di dati utili alla ricerca.
Operatori come Wildlife Adventures organizzano attività di bearwatching con approccio didattico, Ecotur propone trekking come “Discovering the wolf” dedicati al monitoraggio non invasivo, mentre WWF Travel affianca guide e biologi in programmi di sensibilizzazione e raccolta dati.
Non tutti i progetti hanno lo stesso livello scientifico: alcuni sono soprattutto educativi, altri collaborano con programmi di ricerca ufficiali. Per questo è consigliabile verificare sempre la destinazione dei dati raccolti presso il tour operator o gli uffici del Parco.
Archeologia partecipata in Sicilia: riportare alla luce sentieri dimenticati
Nella Valle dei Templi di Agrigento l’offerta di visite si è ampliata oltre la semplice fruizione monumentale: nascono percorsi che combinano natura, archeologia e accompagnamento specialistico, pensati per far comprendere al visitatore il paesaggio storico come risultato di pratiche umane che vanno lette, curate e talvolta ripristinate. CoopCulture, che gestisce servizi, visite guidate e percorsi didattici nel Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, propone esperienze tematiche, audioguide e itinerari fuori orario che valorizzano assi antichi come il Cardo I e la Rupe Atenea.
Il sito ufficiale del Parco segnala la riproposizione di iniziative denominate “ArcheoTrekking” e iniziative di trekking integrato «dei saperi e dei sapori», pensate per coniugare paesaggio naturale, storia e pratiche tradizionali: questi percorsi offrono un approccio più immersivo rispetto alla visita convenzionale, con guide storiche, archeologiche e naturalistiche che ricostruiscono funzioni e relazioni tra elementi del territorio.
Ospitalità circolare: le strutture che trasformano i propri scarti in risorsa
Il concetto di ospitalità circolare si sta diffondendo anche tra gli agriturismi italiani, che non si limitano più a ridurre l’impatto ambientale, ma cercano di chiudere i cicli produttivi interni trasformando gli scarti in nuove risorse. Alcune realtà agricole, ad esempio, hanno scelto di gestire in autonomia i rifiuti organici producendo compost da reimpiegare direttamente negli orti e nei campi coltivati, riducendo l’uso di concimi chimici e restituendo fertilità al suolo.
Un modello interessante arriva dalla Toscana, dove il progetto “Compost Amelia” ha mostrato come il compost ricavato dai rifiuti organici possa essere utilizzato nei terreni agricoli per migliorare qualità e resa, con un monitoraggio attento sugli effetti sui suoli e sui prodotti. Allo stesso tempo, iniziative come il progetto Sircles in Puglia, coordinato dal Consorzio Italiano Compostatori, hanno premiato strutture ricettive che integrano pratiche virtuose di economia circolare, come il recupero dell’organico e l’impiego del compost nei propri spazi verdi.
In molti casi queste realtà organizzano anche workshop per sensibilizzare gli ospiti sul tema della riduzione dei rifiuti e del riuso delle risorse, creando un legame diretto tra esperienza di soggiorno e buone pratiche ambientali. L’uso del compost negli orti, il riciclo delle acque grigie per l’irrigazione e la didattica partecipata rendono così il turismo rurale non solo sostenibile, ma rigenerativo, capace di coinvolgere attivamente le comunitàe i visitatori in un percorso condiviso di cambiamento.
La checklist del viaggiatore rigenerativo: 7 domande da porsi prima di prenotare
Per praticare un turismo consapevole non basta scegliere una destinazione “green”: è fondamentale interrogarsi sul reale impatto del viaggio e sulle scelte che facciamo durante il soggiorno. Prima di prenotare, ogni viaggiatore può porsi sette domande chiave per capire se la propria esperienza sarà semplicemente consumistica o davvero rigenerativa.
1. A chi vanno i miei soldi?
In un approccio estrattivo, il denaro speso confluisce nelle casse di grandi catene internazionali, lasciando scarsi benefici sul territorio visitato. Al contrario, un’esperienza rigenerativa privilegia strutture a gestione familiare o comunitaria, in cui i profitti vengono reinvestiti localmente, supportando la crescita economica e culturale dellecomunità ospitanti.
2. Che tipo di lavoro viene creato?
Il turismo tradizionale spesso genera occupazioni stagionali, poco qualificate e mal retribuite. Nel turismo rigenerativo, invece, si favorisce lavoro stabile e qualificato, valorizzando competenze e tradizioni locali e contribuendo a rafforzare la resilienza economica della comunità.
3. Come interagisco con la comunità locale?
In molti pacchetti turistici convenzionali l’interazione con la popolazione locale è superficiale, spesso limitata a spettacoli o visite rapide. Un’esperienza rigenerativa trasforma il visitatore in partecipante attivo: cucinare insieme a chi vive nel luogo, imparare mestieri tradizionali o condividere attività culturali genera connessioni autentiche e durature.
4. Qual è l’impatto del cibo che consumo?
Il cibo dei circuiti standardizzati arriva da fornitori nazionali o internazionali, con un’impronta ambientale significativa e scarsi legami con il territorio. Scegliere alimenti provenienti da orti locali, produttori a filiera cortissima o Presìdi Slow Food permette di sostenere l’agricoltura locale e di comprendere la cultura gastronomica del luogo.
5. Come viene gestito l’ambiente?
Molti hotel puntano solo a ridurre sprechi immediati, ad esempio cambiando gli asciugamani solo su richiesta. Un’esperienza rigenerativa prevede programmi attivi di ripristino ambientale, come piantumazioni, pulizie dei sentieri o ripristino di habitat naturali, e consente di parteciparvi direttamente, lasciando un impatto positivo concreto.
6. Cosa imparo da questa esperienza?
Il turismo convenzionale spesso fornisce conoscenze superficiali: date storiche, monumenti da vedere, scorci fotografici. Il turismo rigenerativo invece offre competenze reali e una comprensione profonda delle sfide ecologiche, sociali ed economiche del territorio, trasformando la visita in un vero percorso formativo e personale.
7. Come torno a casa dopo il viaggio?
Infine, mentre un viaggio tradizionale lascia il visitatore rilassato e riposato, un’esperienza rigenerativa produce un effetto più profondo: si torna cambiati, con un senso di responsabilità e connessione verso il luogo visitato, consapevoli di aver contribuito al benessere della comunità locale e dell’ambiente.
| Domanda Chiave | Approccio “Estrattivo” (Negativo) | Approccio “Rigenerativo” (Positivo) |
| 1. A chi vanno i miei soldi? | La proprietà è di una grande catena internazionale, i profitti lasciano il territorio. | La struttura è a gestione familiare o comunitaria, i profitti vengono reinvestiti localmente. |
| 2. Che tipo di lavoro viene creato? | Lavoro stagionale, poco qualificato e a basso salario. | Lavoro stabile, qualificato, che valorizza le competenze e le tradizioni locali. |
| 3. Come interagisco con la comunità locale? | L’interazione è superficiale, da “spettatore” (es. cena con spettacolo folk). | L’interazione è autentica e partecipativa (es. corso di cucina con una persona del posto). |
| 4. Qual è l’impatto del cibo che consumo? | Il cibo è standardizzato, proveniente da fornitori nazionali/internazionali. | Il cibo proviene da orti locali, produttori a filiera cortissima, Presìdi Slow Food. |
| 5. Come viene gestito l’ambiente? | L’attenzione è solo sul “risparmio” (es. cambio asciugamani su richiesta). | Esistono programmi attivi di ripristino a cui posso partecipare (es. piantumazione, pulizia). |
| 6. Cosa imparo da questa esperienza? | Imparo nozioni superficiali sul luogo. | Acquisisco nuove competenze e una comprensione profonda delle sfide e delle risorse del territorio. |
| 7. Come torno a casa dopo il viaggio? | Torno rilassato e riposato. | Torno cambiato, con un nuovo senso di connessione e responsabilità verso il luogo visitato. |
Il concetto di ‘Thriving Destination’
Gli esperti di turismo rigenerativo non parlano più di “destinazioni sostenibili”, ma di “Thriving Destinations” (destinazioni prospere). Una destinazione prospera è un luogo dove l’arrivo dei visitatori agisce come un catalizzatore che migliora la salute generale dell’ecosistema e il benessere della comunità, creando un ciclo virtuoso in cui tutti (ambiente, residenti, visitatori) prosperano. (Fonte: The Future of Tourism Coalition).
Il concetto di “Thriving Destination” (destinazione prospera) rappresenta un’evoluzione significativa nel pensiero sul turismo rigenerativo. Mentre il termine “sostenibile” si concentra sulla riduzione degli impatti negativi, “rigenerativo” implica un impegno attivo nel migliorare le condizioni ambientali, sociali ed economiche di una destinazione. Una destinazione prospera è, quindi, un luogo in cui l’arrivo dei visitatori agisce come un catalizzatore per il miglioramento della salute generale dell’ecosistema e del benessere della comunità, creando un ciclo virtuoso in cui tutti, ambiente, residenti e visitatori, prosperano.
Questo concetto è stato promosso dalla Future of Tourism Coalition, un’iniziativa globale che riunisce organizzazioni come il Center for Responsible Travel (CREST), il Destination Stewardship Center, Green Destinations, Sustainable Travel International, Tourism Cares e la Travel Foundation. La coalizione si impegna a mettere le destinazioni e le loro comunità al centro del turismo, utilizzando 13 principi guida per promuovere un cambiamento sostenibile. Questi principi mirano a proteggere gli ecosistemi, onorare le culture locali e sostenere il benessere a lungo termine delle comunità.
Il concetto di destinazione prospera si distingue da altri approcci in quanto non si limita a minimizzare i danni, ma punta attivamente a migliorare le condizioni esistenti. Ad esempio, invece di ridurre semplicemente l’impronta ecologica, si cerca di ripristinare gli ecosistemi danneggiati, promuovere l’inclusione sociale e stimolare l’economia locale in modo sostenibile. Questo approccio richiede una collaborazione stretta tra tutti gli attori coinvolti – autorità locali, operatori turistici, comunità e visitatori – per sviluppare strategie condivise che portino a benefici duraturi.
Lo sapevi? Esistono iniziative in cui i visitatori possono letteralmente “piantare un albero con il proprio nome” e seguirne la crescita anche a distanza grazie a piattaforme digitali. Questo trasforma l’esperienza di viaggio in un legame tangibile e duraturo con il territorio, rendendo il turista parte attiva della rigenerazione e non solo un osservatore.
In sintesi
In turismo rigenerativo trasforma il viaggio in un’opportunità di apprendimento e partecipazione attiva, creando benefici tangibili per ecosistemi, comunità e visitatori. Le esperienze scelte con attenzione valorizzano economie locali, promuovono pratiche sostenibili e rafforzano il senso di responsabilità e connessione verso i luoghi visitati. Questo approccio ridefinisce il ruolo del turista, da spettatore a co-creatore di valore duraturo.
Video: Rilancio turistico a Brunate: al via il Progetto Volta, un modello di “turismo rigenerativo”
Il Comune di Brunate punta sul turismo rigenerativo con il Progetto Volta, selezionato da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia come iniziativa emblematiche del bando Emblematici Maggiori 2024. Il progetto è partito con un finanziamento a fondo perduto di 1 milione di euro.